Stralune di Antonio Errico, storie di anime in pena
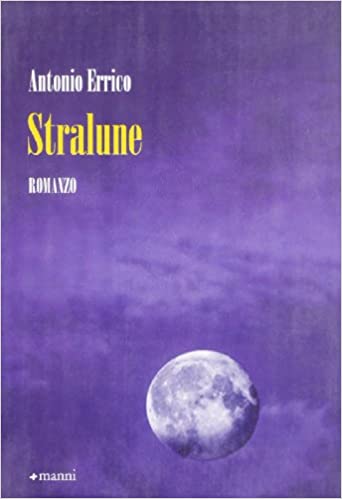
Stralune-di-Antonio-Errico
di Paolo Vincenti
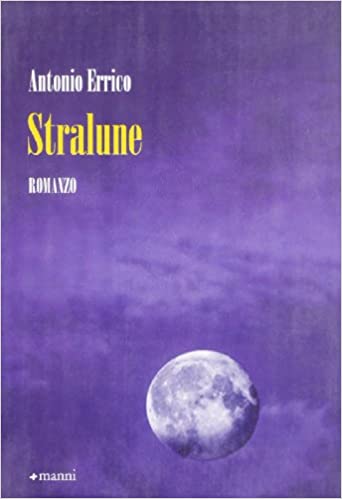
Stralune, di Antonio Errico (Manni Editore 2008), “un romanzo con il linguaggio di un poema. Un poema che ha le storie e i personaggi di un romanzo”, secondo la definizione del suo stesso autore, è un continuo stralunarsi, nel senso di strabuzzare gli occhi di fronte alle sue pagine fitte di una prosa scintillante ed originale, nella sua liricità, e della quale Errico è maestro. Lui che si è abbeverato, durante i suoi studi, alla fonte dei classici latini e greci e poi dei grandi maestri della letteratura italiana e straniera, ed ha fatto l’apprendistato presso quel libero cantiere culturale salentino di cui era capomastro il “fabbricante d’armonie” Antonio Leonardo Verri, ha poi elaborato, negli anni, una propria poetica, affrancandosi dai suoi maggiori – Bodini, Toma, Pagano, Comi, Ercole Ugo D’Andrea, Corvaglia, Fiore, Moro, Bernardini, Durante -, e affiancandoli nel gotha degli scrittori salentini.
Ed ora, dopo quel piccolo capolavoro che è Viaggio a Finibusterre, ormai un classico della letteratura salentina contemporanea, torna al suo pubblico con questo Stralune. Non può sfuggire che nei titoli delle sue due opere più importanti, non so se volutamente, ci sia un rimando al più grande autore salentino di tutti i tempi, Vittorio Bodini: in Viaggio a Finibusterre si può cogliere il riferimento ad una lirica bodiniana molto nota, ovvero Finibusterrae, e in Stralune a La Luna dei Borboni, la sua principale raccolta poetica. Il libro ha già ricevuto moltissimi apprezzamenti dalla critica specializzata e un ottimo gradimento di pubblico. Il protagonista del romanzo è «Un disertore – come scrive lo stesso Errico in quarta di copertina – [che] ritorna nella notte [con] la memoria [che] diventa corpo, diventa voce di madre, di figlia, di amante, di padre, di sé.
Sullo sfondo del tempo, una guerra». Sia il personaggio principale della narrazione, sia la guerra, dalla quale egli ritorna, avendo disertato, che i coprotagonisti dell’opera non hanno nessuna connotazione ben definita ma sono voci, presenze ambigue, eteree, anime inquiete nella notte che le avvolge. E così molto inquietante è l’ombra, coprotagonista del romanzo, che segue dappresso il disertore, lo tallona, si insinua in quegli interstizi dell’anima, quegli intervalli del tempo immobile, e poi scompare come è apparsa, sfugge alla comprensione del protagonista e nostra.
Scrive Valeria Nicoletti su “QuiSalento”, che “Stralune è un libro che si legge a mezza voce. Non si declama per non violarne l’intimità, per non indebolire il vigore di pensieri che da soli stringono la gola.” Non c’è nel romanzo, un momento di massima Spannung, ossia il momento di massima tensione narrativa, poiché per tutta la narrazione, che procede circolare, l’autore ha saputo tenere alta la tensione emotiva del lettore, dalla prima all’ultima pagina. Scrive Daniela Pastore su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, che “dei personaggi di Errico si innamora perdutamente chi ha avuto i vuoti, i silenzi, il tempo notturno per contare i granelli di sabbia di una clessidra. Stralune è poi una partitura musicale. Si legge come fosse una ballata, una musica araba, un canto antico. Il ritmo abbassa la soglia della reattività, induce all’abbandono. E’ una resa totale, alla fine, quella del lettore alla scrittura di Errico, al monologo del suo protagonista, veritiero o mendace che sia”.
Per quanto riguarda lo stile, Antonio Errico ha raggiunto ormai una cifra stilistica che ne fa un indiscusso punto di riferimento nella letteratura salentina e non solo. Questo si deve soprattutto alla sua prosa lirica che è la più originale, suadente, che ci sia oggi in giro. Colpisce soprattutto, nei suoi scritti, l’ipotassi, ossia la riduzione a poche parole di una frase, a volte anche ad una sola parola. Un’altra caratteristica precipua dell’arte di Errico è l’ossimoro, “histeron-proteron”, cioè il paradosso intrinseco alla sua scrittura, di vita-morte, presenza-assenza, fuga-ritorno. E poi l’anafora, l’iterazione, le numerose rime interne, assonanze, consonanze, e i neologismi, come «tralucere», «lucere di stelle», «lumera che arde», ecc. Ancora, il gioco dei calchi, dei richiami che, in certe prose, esprime come una gioia intellettuale dell’autore nel lanciare degli input ai lettori più attenti.
Sul protagonista del romanzo, Antonio Errico scrive in esergo: “Colui che racconta è colui che ha tradito. / Si tenga conto di questo durante il racconto. / Se ne tenga conto quando il racconto è finito”. Questo personaggio, il disertore, è l’epicentro del romanzo. Un personaggio tragico, animato da un cupio dissolvi, che accoglie nella propria figura tutti i riflessi nichilistici di una cultura e di una società che forse volgono al loro tramonto e portano con se, in questo annientamento, anche la vita del protagonista. Ma la sua voglia di sperdersi è una tensione a ricongiungersi con l’infinito Tutto che poi coincide con l’infinito Nulla. Sono diversi i temi presenti nel romanzo. Uno di questi, indicato da Antonio Prete sulle pagine del “Corriere del Mezzogiorno” è il «tema del ritorno». Un altro tema, indicato da Maurizio Nocera, è quello della dimenticanza, anzi della “ricordanza della dimenticanza”, che è un evidente ossimoro, ossia una contraddizione in termini; ma proprio questa è una delle caratteristiche principali del romanzo, come abbiamo già evidenziato, e tutto l’impianto narrativo è sorretto da una contraddizione terminologica fra dire e non dire, fra chiaro e scuro, vita e morte, buio e tenebre, partenza e ritorno. Un’altra importante tematica è quella del tempo, che fa da leit motiv di tutta l’opera: il tempo con le sue variabili, il tempo nelle sue infinite declinazioni, tempo passato, presente, futuro, tempo che passa senza lasciar traccia, oppure che si stratifica e che inchioda, il tempo vissuto e quello immaginato, il tempo passato che rivive nel ricordo, la memoria di un tempo mitico che è l’età dell’oro di ciascuno, ossia l’infanzia e l’adolescenza, oppure il tempo che è stato rimosso dalla dimenticanza, il tempo nel senso fisico, cronologico, fatto di minuti, ore, giorni, oppure quello interiore, fatto di ansie, gioie, dolori, speranze disilluse, il tempo di andare, il tempo di tornare.
Questa tematica è presente non solo, scopertamente, in questo romanzo, ma anche, in maniera meno immediata, negli altri romanzi. Questa sensibilità al passare del tempo accomuna Errico ai più grandi autori della letteratura di tutti i tempi. I vari personaggi del libro parlano ma a noi sembra che si tratti di un sonniloquio, una lunga confessione notturna, e non sappiamo se, alla fine della notte, essi svaporeranno, con le prime luci dell’alba, o resteranno presenze tangibili nella loro vita che non è, non è più, o non è mai stata, la vita del protagonista. Vita sospesa, nella rarefazione delle atmosfere del romanzo, tra la notte con la sua nebulosità dionisiaca, regno delle forze oscure, mistiche e irrazionali, e il giorno, con la sua luminosità apollinea e la sua razionalità.
La scrittura si dipana fra questi due opposti che si attraggono e si respingono, in un libero fluire delle emozioni, che a volte porta anche ad uscire dal senso, a perdere il filo della trama, se una direttrice di scrittura ci possa essere nelle intenzioni dell’autore. In effetti, tutta la scrittura di Errico si caratterizza per questi “sconfinamenti,” per usare un termine che fa parte del suo vocabolario lirico, per un “dereglement de sens”, cioè una libera fluttuazione dei pensieri e delle parole e, a volte, in certi passaggi di più vorticoso narrare, direi quasi che rasenta la scrittura automatica, nel senso heideggeriano secondo il quale non è l’autore a dominare la scrittura ma la scrittura a dominare l’autore, il significante che predomina sul significato. L’occhio attento e la sensibilità allenata dei lettori potranno cogliere nel suo romanzo diverse chiavi di letture che, magicamente, apriranno le porte della percezione, per dirla con William Blake. Un’altra chiave di lettura del libro è quella magica o magico-animistica. Chi è il protagonista? È vivo o morto?
E i personaggi con i quali si rapporta, sono vivi o morti? Questo non è possibile stabilirlo, nell’intersecazione dei piani narrativi fra l’osservazione oggettiva del mondo e quella interiore, psicologica, del personaggio narrante. In questa intersecazione, vengono meno anche le differenze fra mondo esterno e mondo interno, tra memoria e attesa del futuro. Mi viene in mente la trama di quel bellissimo film che è The Hours, con Nicole Kidman. Perciò io definirei questo romanzo un “giallo psicologico”. Un giallo irrisolto, senza nessuna epifania interna, senza riscatto finale del protagonista, che ritroviamo in una sorta di caserma dei carabinieri che lo hanno trovato in evidente stato confusionale su una fredda panchina del centro e lo hanno condotto in centrale dove lo interrogano, con aria stralunata anch’essi, come stralunato appare il protagonista fino all’ultimo rigo del libro.
Una diversa chiave di lettura può essere quella autobiografica. Di autobiografico, ma non stricto sensu, c’è il rispecchiarsi dell’autore in questo disertore, nella sua complessa vicenda esistenziale. Ritornando alla “ricordanza della dimenticanza”, appare significativo il lungo monologo della madre del protagonista: “Dimentica i tuoi aquiloni, i giochi nei cortili, il tempo della semina, il mosto dentro i tini, i tamburelli nella notte, le barche di carta, il nano di legno che scendeva dalle scale, dimentica quante volte non hai saputo capire, dimentica quante volte non hai saputo ascoltare, dimentica tutti i giorni che hai pensato di fuggire, tutte le notti che hai sognato di tornare, dimentica la luce delle albe di aprile, poi tutto quello che non vorresti mai dimenticare, fai come se dovessi dimenticare la tua carne, come se dimenticassi che hai sangue nelle vene, dimentica tutto il bene che mi hai voluto e ti ho voluto, il male che ti ho fatto non venendoti a cercare”. Si potrebbe parlare di una “elegia della dimenticanza”, che mi fa venire in mente un brano di un poeta cantautore, che Antonio Errico come me frequenta molto. Il cantautore è Roberto Vecchioni e il brano è Dimentica una cosa al giorno, in cui Vecchioni dice alla madre le stesse cose che la madre del romanzo di Errico dice al figlio. Il ritorno sui propri passi del protagonista, sempre in bilico fra perdersi e ritrovarsi, risulta molto doloroso, perché lui, ormai, è diventato straniero nella propria terra, che è diventata anch’essa una “Wastland”, una terra fredda e inospitale.
A maggior ragione, doloroso questo ritorno; infatti, per dirla con un altro cantautore molto amato da Antonio Errico, ossia Francesco Guccini: “non bisognerebbe mai ritornare…”
PAOLO VINCENTI
Pubblicato in “Il Paese Nuovo”, 14 novembre 2009







