Seconda e ultima parte di “Edmondo dei languori” tratto da “Artemisia e altri cinque racconti” di Vincenzo Fiaschitello
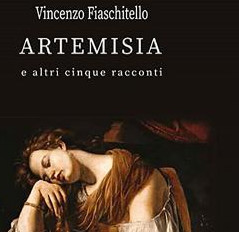
Artemisia un libro di Vincenzo Fiaschitello
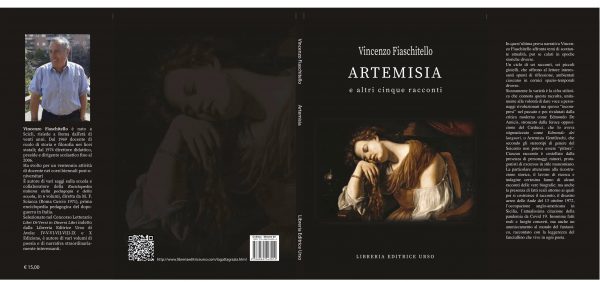
Presi il cappello e uscii di casa, sbattendo la porta.
Quando uscivo di casa, irritato dopo una lite furibonda con Teresa, andavo al parco Valentino a smaltire la rabbia che mi bolliva dentro. Camminavo a gran passi e man mano che mi calmavo, rallentavo e provavo a pensare al disagio di Furio che creava una così grave apprensione alla madre e lacerava il mio animo. Mi dicevo che in fondo volevo bene al mio ragazzo e che non c’era nulla di vero nelle accuse che mi aveva mosso quella “pazza”. Non avevo mai intralciato la sua passione dello scrivere e non ero mai intervenuto presso i miei amici né a suo favore, né tanto meno a suo danno. Anzi io avrei voluto che concentrasse le sue energie verso la medicina che allora come adesso promette stima, riconoscimenti e ottima posizione sociale. Lo avevo visto sin da piccolo, predisposto alla osservazione della natura, a propormi mille “perché”, tutti segni di curiosità che potevano sfociare in un interesse scientifico. Meglio un bravo medico, che un cattivo letterato. Così pensavo. E tuttavia spesso ero preoccupato perché in più di una occasione avevo anch’io capito che portava dentro di sé una pena: guardava a volte nel vuoto, sembrava non ascoltarmi, tardava a rispondere alle domande che gli rivolgevo. Non potevo negare che anch’io ero preoccupato per lui.
Un giovane di ventidue anni che si uccide, lascia sempre in chi resta un vuoto incolmabile, interrogativi dolorosi, una sofferenza indicibile per coloro che lo hanno amato. Lo trovarono un mattino di novembre disteso su una panchina del parco con un foro alla testa, causato da un colpo di rivoltella. Lo riconobbero all’ospedale i suoi compagni di studio come Furio De Amicis, figlio dello scrittore.
Se un giovane decide il suicidio è perché ha perso ogni speranza di futuro; la smania interiore, via via sempre più ridotta per lo scacco e per la durezza di continue sconfitte, si è del tutto spenta. Non c’è più ragione di proseguire. E’ meglio fermarsi definitivamente.
Nei giorni seguenti mi ritrovai a percorrere a lungo i viali del parco; passavo e ripassavo dinanzi a quella panchina, la guardavo con gli occhi umidi di pianto, la toccavo. Facevo scivolare la mia mano per tutta la sua lunghezza, ma non trovavo quiete. Se avevo rimorsi? Non mi rimproveravo nulla. Anche se la mia presenza in casa era stata carente, tuttavia riconoscevo che non gli avevo fatto mancare né consigli, né sostegno alcuno. E allora che cosa mi procurava quell’angoscia che ottenebrava tutto il mio essere, che mi faceva anche barcollare in certi
momenti fino ad essere costretto a trovare un appoggio, un albero, il muro di cinta, per impedirmi di cadere? Era una sofferenza sottile, impercettibile ma penetrante come nebbia fredda autunnale, che provavo al pensiero che per ognuno di noi, anche l’essere amato resta sempre un ignoto, estraneo e indecifrabile, malgrado ogni nostro impegno ad amare, a offrire il nostro aiuto disinteressato. Provavo la sensazione di un estremo abbattimento all’idea degli ultimi istanti di vita del mio figliolo. Sentivo il freddo della sua mano che toccava la rivoltella nascosta nella tasca del suo cappotto, immaginavo la sua definitiva risoluzione a uccidersi in quel giorno, in quel preciso momento, la sua ultima visione dei rami spogli dell’albero accanto alla panchina, testimone della sua agonia, l’ultimo pigolio di un passero che saltellava attorno e che di lì a un istante dopo, sarebbe fuggito spaventato dal secco rumore dello sparo che avrebbe devastato il cervello del mio povero ragazzo.
Fu a partire da quel tempo che cominciai a provare nausea e vergogna di quella mia vita tutta cuore e fallo.
Teresa, mia madre, era scomparsa da pochi mesi. Di lei, anni prima, avevo scritto: Non sempre il tempo la beltà cancella/ O la sfioran le lacrime e gli affanni;/ Mia madre ha sessant’anni,/ E più la guardo e più mi sembra bella./ Non ha un detto, un sorriso, un guardo, un atto/ Che non mi tocchi dolcemente il core;/ Ah se fossi pittore/ Farei tutta la vita il suo ritratto… Era una poesia che amavo rileggere spesso e tutte le volte provavo una viva commozione. Quando la prima volta gliela lessi, ricordo che pianse e mi abbracciò.
In quei giorni, dunque, sentivo crescere la volontà di por fine alle sregolatezze della mia vita sentimentale: tante donne erano entrate nella mia vita e ciò aveva fatto soffrire mia moglie che mi accusava di ipocrisia e di incoerenza. Mi assolvevo con eccessiva superficialità. Ma che potevo fare se il mio cuore mi trascinava impetuosamente al sopraggiungere di un sentimento che mi faceva ardere di entusiasmo e di passione?
Ora, dopo la morte di Furio e quella di mia madre, mi ero separato dalla moglie. Avevo per sempre lasciato la casa, senza però poter portare con me alcune mie cose cui tenevo molto. La piccola scatola di metallo che non avevo più potuto aprire perché deformata, ridotta a un pezzo di metallo schiacciato, contenente i biondi capelli di Giuditta, stava sempre sopra il mio tavolo di lavoro, accanto a fogli sparsi e a libri aperti. Un giorno non la ritrovai più. La cercai invano, chiesi se qualcuno l’avesse
vista, ma negarono. Capii che l’autrice del misfatto era Ernestina, la donna che curava i servizi della nostra casa, ma sicuramente su ordine della padrona. I conflitti continui, i lutti recenti, il fallimento del matrimonio, gli anni che sembravano sempre più accelerati, mi avevano indotto ad ammettere che la vecchiaia fosse alla porta. E con il suo arrivo sentivo che stavo per perdere il privilegio di un sonno tranquillo e benefico, senza interruzione. Tardavo a prendere sonno la sera, mi svegliavo al mattino con la sensazione di non aver riposato affatto e di non ricordare alcun sogno. Ma uno lo ricordavo. E poiché era ricorrente, finì con l’ossessionarmi. Nel sogno di solito mi trovavo seduto in poltrona, vicino al caminetto. Tenevo sulle spalle una coperta, leggevo un libro. Di tanto in tanto alzavo gli occhi e seguivo il fumo che si alzava da un ciocco che non riusciva ad accendersi bene. Ed ecco che tra le volute di fumo, mi apparivano delle figure che, oscillando, si allontanavano rapidamente. Poi si avvicinavano sempre più ferme e precise. Silenziose, sfilavano sotti i miei occhi e ritornavano. Infine ne riconobbi una. Non poteva essere che lui, Franti, il malvagio sempre pronto a fare la guerra con tutti, a offendere, a minacciare, a mettere in ridicolo gli atti di eroismo, di compassione, a svalutare un gesto di scuse e di sottomissione, a non avere alcun rispetto per le gerarchie sociali. Il profilo di quella figura, ora, emergeva con maggior precisione e faceva sentire il suo sorriso beffardo che irrideva la morale dei buoni sentimenti:
-“Ehi, amici, guardate Edmondo il nostro povero autore com’è ridotto! Ha finito finalmente di raccontarci storie melense, di disegnare una figura così perfetta come te, il mio Garrone, con quel testone tutto pieno di bontà e di altruismo, pronto sempre ad aiutare i gobbetti, gli sciancati e i poveretti. Ma via, Edmondo, hai creduto veramente che potesse esistere un tipo come lui? Non ti pare che, se un giorno gli gira male, si stanca e se qualcuno gli chiede un aiuto, lo ignora o peggio gli si rivolta contro? Eh via, Edmondo, ma ti pare giusto che a quel Derossi tutto vada bene, pronto, intelligente, primo della classe e che mai un giorno gli capiti di fare un compito sbagliato, che mai si becchi un rimprovero del maestro? Guarda me, caro il mio autore, io tutto malvagio? Dalla testa ai piedi? Io, incapace di imitare le azioni della piccola vedetta lombarda o del piccolo patriota padovano? Ponendomi in così cattiva luce, avresti potuto cogliere l’occasione per disegnare il migliore dei tuoi personaggi,
il più vicino alla realtà: perché non ti sei domandato la ragione della mia violenza, della mia ribellione? Io potevo essere il personaggio più significativo come colui che si ribella alle scandalose differenze sociali, alla ubbidienza vile e degradante, al rispetto di regole dettate da pochi interessati privilegiati a danno dei molti.
Quando mi svegliavo, talvolta pur sbalordito per ciò che quel malvagio Franti fosse riuscito a vomitare dal suo inferno interiore, mi pareva che in un certo senso non avesse poi torto. Avevo creato dei manichini, rigidi e fissi nei loro sentimenti e comportamenti; poi però mi rasserenavo dicendomi che in fondo era necessario nel momento storico in cui ci trovavamo. Tutto era fragile perché appena nato: lo Stato, le istituzioni come l’esercito, la scuola, la giustizia. Era estremamente urgente che con la forza della parola scritta il pubblico venisse trascinato al rispetto, all’amore, al bene di ciò che con grande fatica si stava costruendo. E a coloro che come i clericali che avversarono il mio libro perché non c’era un alito religioso (non c’è nel diario di Enrico nessun ricordo di evento religioso, come Natale, Pasqua, ecc.), faccio osservare che tra Chiesa e Stato, di fatto c’era e c’è tuttora uno stato di belligeranza, il che giustificava l’ostracismo di principi e riti religiosi dalla scuola pubblica. Già all’epoca del mio viaggio in Argentina, avevo toccato con mano il triste problema dell’emigrazione. Tanti nostri connazionali avevano scelto quella strada per fame e per desiderio di riscatto dalla povertà e dalla miseria. Nella terza classe del piroscafo, un puzzo di sudiciume esalava da un mucchio di rifiuti umani. C’era dolore, ansia, paura, rabbia, come se tutta l’umanità derelitta si fosse concentrata in quel ventre di nave che solcava le onde dell’oceano. I pianti dei più piccoli in braccio alle donne si incrociavano con le urla degli adulti, con le imprecazioni, con le bestemmie. Dappertutto sporcizia: un tanfo di morte si levava da quei corpi accovacciati, stretti gli uni agli altri in mezzo a “un concerto di lamenti, di rantoli e di tossi”.
Raccolsi le mie impressioni nel libro Sull’oceano, dove appunto descrivevo quelle scene che suscitavano la commozione per le sofferenze e le umiliazioni subite dai protagonisti. Tutto ciò si rivelava come una vera epopea con al centro una struggente nostalgia per la terra delle radici. Ebbene quegli eventi mi spinsero a condividere le idee del nascente socialismo. Riconobbi in Filippo Turati, direttore della rivista Critica sociale, l’uomo che spendeva tutta la sua intelligenza nell’ideare un sistema di vita democratica, nel quale le ingiustizie sociali fossero
ridotte al minimo, un sistema nel quale ciascuno potesse realizzare se stesso nel rispetto dell’altro, senza invidie e odi, per assicurare la pace all’umanità. Turati fu per me anche un ottimo amico. E a lui confidai tutti i miei guai familiari: la morte di mia madre, quella di mio figlio, le continue e distruttive liti con mia moglie, la quale, accecata dalla gelosia, vedeva nel movimento di emancipazione femminile, incoraggiato dal socialismo, la presenza di donne senza scrupoli morali, pronte ad allontanare i mariti dalle proprie mogli.
Del tema della emancipazione femminile scrissi anche nel resoconto del mio viaggio a Costantinopoli, illustrando le condizioni e i costumi delle donne turche che appena ne hanno la possibilità cercano di conoscere le signore europee, “queste donne straordinarie che studiano tante cose, che dipingono, che scrivono per le stampe, che lavorano negli uffici pubblici, che montano a cavallo, che salgono sulla cima delle montagne…”. Ora le donne turche si vergognano della propria ignoranza e vogliono sempre più imitare le europee nel vestire e nei modi.
Non posso negare che a me piaceva molto essere ammirato, stare al centro dell’attenzione, ricevere lodi, specialmente dalle donne. Ricordo con gratitudine una donna che non si stancava di ammirarmi e di farmi ammirare in quel salotto rosso di Firenze, che fu per me il luogo dove potei consolidare le mie idee sulla lingua e dove trovai ispirazione per una gran parte dei miei argomenti intrisi degli ideali di amore per la patria, di eroismo, di solidarietà, di attaccamento al dovere. Emilia Peruzzi Toscanelli, l’animatrice di quel cenacolo, ebbe per me una grande stima che fu decisiva per la mia affermazione di scrittore. Nel suo salotto conobbi letterati, scienziati, politici. E finché Firenze fu la capitale, si aveva l’impressione che la sua casa fosse una sorta di succursale del parlamento, dove venivano dibattuti i problemi della vita reale. Fu anche quella preziosa esperienza che più tardi mi fornì una più matura consapevolezza e un orientamento a favore degli operai e dei più poveri, aderendo al socialismo.
Man mano che mi avvicino ai sessant’anni sono più disponibile a riconoscere che certi aspetti della mia personalità probabilmente in futuro verranno ritenuti sgradevoli, incoerenti e censurabili. Primo fra tutti la passione amorosa che si avverte, se non proprio in ogni pagina, in quasi tutti i miei racconti anche in quelli che possono sembrare più insospettabili. Nello stesso racconto de La maestrina degli operai c’è sempre una palpitazione segreta sensuale, come pure, più o meno
velatamente, in certe figure femminili presenti sul piroscafo Galileo in navigazione sull’oceano e in altri racconti come quello dal titolo Camilla. Ma tant’è. La mia natura mi inclinava a mantenere questa tendenza che mi figuravo di portarla con me fino all’ultimo, al punto di scrivere in chiusura del viaggio a Costantinopoli: “Vecchio come sono, non ho ancora rinunziato alla speranza di dare il braccio alla moglie d’un pascià di passaggio per Torino, e di condurla a passeggiare sulle rive del Po, recitandole un capitolo dei Promessi Sposi”.
Da Catania un giorno mi giunse una lettera dall’amico siciliano Mario Rapisardi, mio antico compagno d’arme nella sfortunata battaglia di Custoza. Da giovani ci eravamo frequentati a lungo presso la casa di Emilia Peruzzi a Firenze, nella quale si andava delineando il nostro futuro di poeti e scrittori. Lì, avevamo conosciuto Giselda Fojanesi, una donna bellissima, giovane e affascinante. Il focoso catanese se ne invaghì e brigò per farla assumere come insegnante presso il Convitto nazionale di Catania.
-“Ma Giselda, disse Rapisardi, non può fare questo lungo viaggio da sola. Io non posso, tu hai i tuoi impegni. Non so proprio come poterla aiutare”.
Mi venne in mente che in quei giorni si aggirava tra i salotti letterari di Firenze Giovanni Verga. “Senti, dissi all’amico, perché non provi a chiedere al tuo concittadino se nei prossimi giorni ha intenzione di tornare a Catania. Sarebbe una buona combinazione farla accompagnare da lui”.
Rapisardi restò un po’ a pensarci, poi disse: “Ma sì, credo proprio che posso fidarmi di Verga”.
A dire il vero, l’insegnante Giselda non era per nulla intimorita dalla eventualità di viaggiare da sola, come neppure era particolarmente attratta dall’idea di avere un accompagnatore. Apparteneva a quel nuovo genere di donne che amano la libertà, sicure di sé, pronte se necessario a dare battaglia a chiunque volesse sottometterle. Sin da quel tempo, infatti, era vicina al movimento della emancipazione femminile e vantava una stretta amicizia con Matilde Serao.
Al suo rientro a Catania, Rapisardi volle sposare la bellissima Giselda. Il matrimonio non fu dei più felici. Presto emersero gli attriti fra le due opposte personalità: lui, geloso e possessivo, tutto preso dai suoi versi, chiuso e riservato; lei, libera, capricciosa, amante della vita di società,
continuamente in contrasto con la suocera. Quando Giselda, nonostante il divieto del marito, si ostinava a uscire da sola o con un’amica per via Etnea, tutti i giovani catanesi e i meno giovani, si mangiavano con gli occhi quella figurina alta, slanciata, dalle movenze simili a una dea dell’Olimpo. Qualcuno, cedendole il passo, accennava a un inchino e si toglieva il cappello; qualche altro osava salutarla e le offriva un mazzetto di fiori di gelsomino profumato. Entrava e usciva dagli eleganti negozi della più bella via della città, quasi sempre sorridente e soddisfatta per gli acquisti effettuati.
Accadde un evento che fece traboccare il vaso: Rapisardi scoprì che Giselda lo tradiva con il suo vecchio amico Verga. Nero su bianco, così assicurava la lettera anonima che un mattino ritirò dalla cassetta della posta. Non ci pensò due volte l’afflitto e amareggiato Rapisardi. La licenziò, cacciandola da casa, come l’ultima delle servette. Quanto al confronto con Verga, rimuginò a lungo se e come vendicarsi.
La situazione si chiarì presto. La tresca tra Giselda e Verga c’era stata ed era durata piuttosto a lungo. Ma la storia della lettera anonima ebbe una svolta che nessuno si aspettava. Sorse il sospetto che quella lettera l’avesse scritta lo stesso Verga, sicuro che avrebbe avuto l’effetto sperato: la cacciata di Giselda sia dalla casa di Rapisardi, sia dalla sua.
Con un colpo solo i due ex amici si erano liberati della avvenente e “scandalosa” aretina.
Rapisardi mi invitava a raggiungerlo in Sicilia non solo per il piacere di riabbracciare un vecchio amico, ma anche per avere con l’intellettuale De Amicis uno scambio di idee sulla lingua, sulla letteratura, sulla scuola, sul socialismo.
Il mio ritorno in Sicilia dopo molti anni fu veramente ricco di soddisfazioni. Rapisardi non perdeva occasione per presentarmi ai suoi amici come uno scrittore di fama internazionale, come anticlericale, socialista e come intellettuale semplice e sensibile. Sottolineava in particolare questo ultimo aspetto per rafforzare la sua avversione al Carducci, suo nemico giurato. E se capitava che polemicamente qualcuno gli ricordasse che a Catania per i suoi meriti di poeta e scrittore era stato chiamato “vate etneo”, andava su tutte le furie e precisava che quella espressione lui l’aveva rifiutata e condannata.
Durante le nostre passeggiate lungo i viali di villa Bellini, Rapisardi elogiò i miei scritti, comprese perfettamente come il libro Cuore ebbe il successo che meritava, ma era il frutto di una azione educativa che si
inquadrava sullo sfondo di una precisa stagione sociale e politica, ormai trascorsa. Considerava il fatto che avessi abbracciato le idee socialiste come il segno più evidente di una raggiunta maturità e del superamento del nazionalismo. Riteneva che l’amicizia con Turati mi avesse convinto che occorreva lottare per un socialismo buono e giusto contro il capitalismo, la violenza, l’egoismo, l’ineguaglianza sociale. Io concordavo con quella analisi che faceva l’amico, perché in fondo si trattava di quelle stesse idee sulle quali andavo riflettendo per un libro che avrebbe aiutato la causa socialista in Italia, un’opera dal titolo significativo: 1° Maggio. Il progresso sociale poteva attuarsi mediante un riformismo graduale che doveva favorire la conciliazione tra le classi.
Anche sul tema della scuola, le nostre idee avevano molti punti in comune. Entrambi eravamo pienamente d’accordo sul grande beneficio che l’educazione del popolo avesse ricevuto con l’istituzione di una scuola dello Stato e non più della Chiesa, di una scuola obbligatoria come il ministro Coppino, già dal 1877 aveva voluto, superando i tentativi piuttosto blandi di norme precedenti rimaste inapplicate con la legge Casati del 1859 e sostituendo l’insegnamento della religione con
“le prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino”.
Ciò che fino a quel momento avevo scritto sulla scuola a cominciare dal diario di Enrico del libro Cuore, del Romanzo di un maestro, della Maestrina degli operai, era frutto di nobili slanci dello spirito, di aspirazioni ideali; ora era il tempo di ideologie filosofiche come il Positivismo, di visioni di orizzonti politici come il socialismo, che obbligavano a misurarsi con la dura e crudele realtà per poterla cambiare, riformare in direzione più umana e giusta. A sigillare il nostro pieno accordo su queste idee, gli ricordai che nella sua lettera di invito a venirlo a trovare a Catania aveva scritto: “che la scuola, istituto di massima importanza nella vita pubblica, dovesse essere fucina di valori morali e palestra di educazione delle giovani generazioni e che non potesse essere estranea alla vita”.
Le espressioni lusinghiere che Rapisardi mi rivolse per le mie opere mi fecero molto piacere. Una in particolare mi colpì. Diceva che il racconto “Camilla” gli era piaciuto molto, soprattutto per la modalità con cui avevo risolto, nella narrazione, lo stato di pazzia di quella donna. E mi aveva posto domande sul dove e sul quando avessi appreso quelle conoscenze di psichiatria. Gli ricordai che alcuni anni prima avevo
visitato Parigi e che in quella occasione, tramite alcuni amici, ero stato presentato al famoso neurologo J.Martin Charcot, il quale ebbe la cortesia di parlarmi delle sue teorie sull’isteria e sull’ipnosi, che trovai molto interessanti, e mi illustrò anche alcuni casi di pazienti presenti nell’ospedale psichiatrico Salpetrière da lui diretto.
Prima di congedarmi, aggiunse che molti medici, anche stranieri, venivano a visitare il suo ospedale e ad assistere alle sue lezioni, per cui era sicuro che questa nuova scienza avrebbe avuto in futuro un notevole sviluppo.
Alcuni giorni dopo, lasciando la Sicilia, abbracciai il vecchio amico Rapisardi e ci separammo con la speranza di poterci ancora rivedere, anche se credo che entrambi in quel momento pensavamo alla impossibilità di un nuovo futuro incontro.
Caro Stefano, fin qui il Memoriale. Forse lo scrittore non ebbe il tempo di continuare e magari aggiungere la sua volontà di istituire delle borse di studio per i ragazzi più bisognosi. Comunque sappiamo da altre fonti che la sua generosità fu veramente straordinaria, come pure l’impegno del figlio Ugo che volle rispettare la volontà paterna di trasmettere l’intera eredità al comune di Torino per aiutare i più poveri. Si trattava di una somma ingente, depositata presso una banca di Lugano, costituita con i diritti d’autore, un patrimonio ammontante a circa tre miliardi di lire. A tutt’oggi, nonostante varie ricerche e processi, l’eredità è avvolta nel mistero. Il comune di Torino, come si può leggere su La Repubblica del 6 novembre 1984, è entrato in possesso solo di una minuscola parte di questa eredità.
Da Vincenzo Fiaschitello: Artemisia e altri cinque racconti, Avola, Libreria Editrice Urso, 2021 pp.85-106






