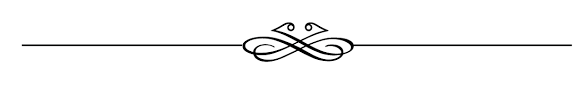Prima parte di “Edmondo dei languori” tratto da “ Artemisia e altri cinque racconti” di Vincenzo Fiaschitello
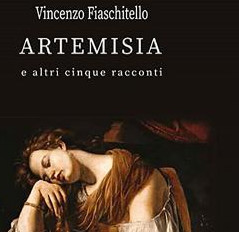
Artemisia un libro di Vincenzo Fiaschitello
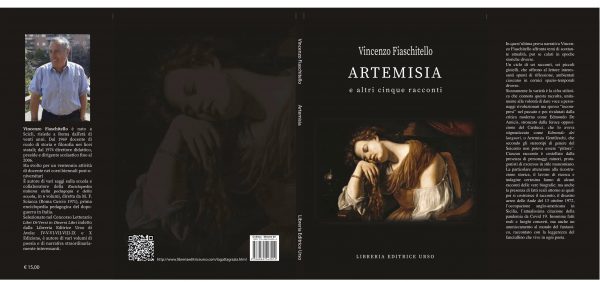
Caro Stefano,
oggi è un giorno importante per te. Ti sei iscritto all’università, mi hai manifestato tutto il tuo entusiasmo per la scelta fatta. Io l’ho condivisa. A essere sincero, se solo ripenso a qualche anno fa, non ci speravo davvero. Nel volgere di poco tempo, ho visto crescere e maturare i tuoi interessi per la letteratura. Ricordo ancora il giorno quando frequentavi la scuola elementare e ti offrii il libro Cuore, che custodivo gelosamente nella mia biblioteca. Lo sfogliasti distrattamente, poi me lo restituisti dicendomi che la tua maestra ti aveva già incaricato di leggere un altro libro.
-“Nonno, mi dicesti, lo leggerò d’estate durante le vacanze. Però è strano che la mia maestra non l’abbia suggerito a nessuno dei miei compagni di classe. E invece tu mi dici che è un libro bellissimo che milioni di ragazzi hanno letto”.
Lo leggesti anche tu, la sera, sacrificando un po’ del tuo tempo libero da internet e da visioni di film di cartoni animati e di guerre stellari. Anche tu, come innumerevoli altri lettori, restasti commosso dalle vicende narrate. Il “buon Edmondo” aveva saputo entrare anche nel tuo cuore di fanciullo con delicatezza e sapienza di educatore.
Da allora sono trascorsi tanti anni; ora sei pronto per esprimere un giudizio su questo libro e sulle altre opere che De Amicis ci ha lasciato.
Io credo che questo Memoriale, che per caso ho trovato sulla bancarella di un mercatino di quartiere e che qui ti accludo, ti potrà essere utile per conoscere meglio la personalità di questo scrittore e poeta che purtroppo da qualche tempo è stato ingiustamente dimenticato.
Memoriale
Il mio nome è Edmondo, Edmondo dei languori, come ironizzò Carducci, il grande vate d’Italia, che così volle umiliarmi. Ma io non raccolsi la sfida. Mi accusò di sentimentalismo e di moralismo patetico, di scrivere storie strappalacrime, di prosa retorica, di usare una lingua popolare con uno stile dimesso, scarsamente fantasioso e puramente
descrittivo. Io, che non amavo le polemiche in pubblico, risposi dichiarandomi suo ammiratore. Tanto bastò per assicurarmi comunque la sua amicizia. Ma perché lo aveva fatto? Sapeva che in fondo ero un giornalista, che scrivevo per il pubblico; un pubblico di non grande cultura, di sentimenti semplici e schietti, che guardava alla realtà senza troppi “distinguo”. Credo che un pizzico di invidia avesse invaso il suo nobile animo. Una prosa come la mia, che trattava dei problemi concreti della vita quotidiana: la scuola, la città, i viaggi, la vita militare, la famiglia, il lavoro, la povertà, la patria, interessava molto al popolo. I miei libri, nonostante le critiche malevoli, si vendevano non solo in Italia, ma anche all’estero. Il libro Cuore, in poco tempo, ebbe un numero straordinario di edizioni e venne tradotto in tutti i paesi del mondo. L’editore Treves aveva fiutato il grande affare; ricordo che ancora prima che gli consegnassi il manoscritto, condusse una straordinaria campagna pubblicitaria, preparando il pubblico ad accogliere il libro che poi si rivelò un capolavoro.
Ciò non poteva non suscitare invidie e risentimenti. Alcuni critici, miei detrattori, non solo mi attaccarono per il moralismo e il didascalismo, ma per essermi dichiarato seguace delle idee manzoniane sulla lingua. Per essere chiaro, a me piaceva tanto l’immagine che usò il Manzoni quando disse che prima di far ristampare il suo capolavoro Fermo e Lucia, occorreva andare a Firenze a risciacquare i panni in Arno. Ecco, la lingua dello scrittore doveva essere una lingua viva e l’esempio migliore era quello della lingua parlata dai fiorentini, una lingua sempre in evoluzione, mai codificata una volta per tutte, una lingua museo, incrostata da inutili raffinatezze, da asperità lessicali, non una lingua aulica. Quel genere di lingua, io lo lasciavo al Carducci.
Furono anni di aspre polemiche, intervennero studiosi come il glottologo Graziadio Isaia Ascoli, Francesco D’Ovidio ed altri, con i quali certo io non mi sentivo di competere. Gli stessi fiorentini, tuttavia, si meravigliavano quando constatavano che in fondo quel modello di lingua fiorentina non lo riscontravano nella loro stessa parlata. A poco a poco la dolente questione della lingua, che si trascinava addirittura dal lontano Trecento, trovò un certo equilibrio allorché si cominciò a capire che la ragioni, per cui l’Italia non avesse ancora una unità linguistica, andavano ricercate nella mancanza di una unità politica e culturale.
Si chiamava Giuditta, la prima ragazza che infiammò il mio cuore di
adolescente soldato. Avevo dovuto lottare tanto a casa per ottenere il permesso da mio padre per dedicarmi alla carriera militare. La mia passione era nata un giorno di festa quando il nostro cocchiere fermò la carrozza ai lati della strada per consentire il passaggio di uno squadrone di cavalleggeri. Mia madre lanciò dal finestrino un mazzetto di fiori che colpì al petto un soldato dall’alto del suo cavallo. Quello sorrise e ci salutò. Non passò molto tempo che un mattino, sentendo bussare alla porta, andai ad aprire. Davanti a me stava quel soldato, vestito in abito borghese che, impacciato e pallido in viso, chiese di poter salutare mia madre. Fu un incontro che lasciò in me una grande impressione. Quell’uomo non aveva le mani e raccontò l’azione militare nel corso della quale aveva subito la menomazione. Fu l’ammirazione per quel gesto eroico che mi spinse a scegliere la vita militare. Più tardi rievocai l’episodio in uno dei miei racconti de La vita militare.
Ottenuto il consenso paterno, a sedici anni potei frequentare l’Accademia militare di Modena e ne uscii con il grado di sottotenente. Era l’estate del 1865. Ricordo che io e il mio amico Francesco camminavamo per le vie di Modena, superbi per la nostra splendida uniforme con chepì e spadino. La gente, passando vicino, ci salutava con rispetto. Le ragazze ci guardavano ammirate, alcune sfacciate sorridevano guardandoci negli occhi, altre più timide abbassavano lo sguardo quando eravamo a poca distanza. I nostri discorsi vertevano soprattutto sulla patria e sulle donne. Le parole dei professori e in particolare quelle del Magg. Generale Ferrero, comandante dell’Accademia, mulinavano nel nostro cervello e, come ci avevano detto più volte, dovevamo essere pronti a difendere la patria e a partecipare a una probabile prossima guerra di liberazione.
Quel giorno eravamo usciti dall’Accademia con l’intento di raggiungere lo studio fotografico di Gaetano Sorgato, in una via alle spalle del bellissimo Duomo e della Ghirlandina. In quegli anni Modena cominciò a costruirsi una gran fama di città della cultura dell’immagine. Il signor Sorgato aveva a lungo studiato l’arte fotografica di Robert Rive, che operava a Napoli, ed era riuscito a vincere la concorrenza dei fratelli Orlandini, divenendo esclusivo referente per la fotografia dell’Accademia militare.
-“Vi prego di accomodarvi e di attendere qualche minuto”, disse il signor Sorgato.
Poco dopo, da dietro una tenda, vedemmo spuntare due belle ragazze: una bruna, l’altra bionda. Entrambe sorridenti, ci salutarono non appena scattammo in piedi portandoci la mano alla visiera.
A differenza del mio amico che nella foto assunse un aspetto serio e solenne, io apparivo con un leggero sorriso, nonostante i continui inviti del signor Sorgato che, insoddisfatto della inquadratura, tirava fuori la testa da sotto il telo per suggerirmi di cancellare quella parvenza di sorriso che mi faceva assomigliare più a un collegiale che a un soldato. Il motivo? Mi ero innamorato della ragazza bionda e il solo pensiero mi dava una gioia che non potevo raffrenare e la manifestavo sul mio viso. Il fotografo finì il suo lavoro. E io lo tempestai di domande: Chi era quella ragazza? Quale era il suo nome? Dove abitava?
-“Piano, piano, disse il signor Sorgato, io sono un professionista, non posso dare informazioni sui miei clienti!”
Ero disperato. Prima di lasciare il suo studio, aiutato anche dal mio amico che si era commosso per tanto sincero trasporto, finalmente Sorgato mi dette una informazione utile. Giuditta (questo era il suo nome) tutte le domeniche andava a messa al Duomo alle undici con la famiglia. Ringraziai vivamente Sorgato e lo pregai di preparare anche una foto di piccola dimensione oltre a quelle formato cartolina.
La domenica seguente, qualche minuto prima delle undici, io e Francesco eravamo dinanzi al Duomo. Fummo fortunati. Dopo poco vidi la bella Giuditta che con i suoi genitori entrava in chiesa. Mi riconobbe subito e mi sembrò che mi sorridesse. In chiesa i nostri occhi si incrociarono più volte e nacque una intesa fatta di sguardi e di sorrisi appena accennati. La cosa si ripeté per due o tre domeniche successive. Poi decisi un gesto di maggiore audacia. Sul retro della foto piccola, che il signor Sorgato mi aveva preparato scrissi con elegante grafia: “A Giuditta, con amore imperituro. Il mio nome è Edmondo e fra qualche giorno partirò per la guerra”. Preparai un piccolissimo pacchetto e aspettai la domenica. Riuscii a trovare posto nel banco dietro a quello dove erano seduti Giuditta e i suoi genitori. E nella piccola confusione che si crea in chiesa al momento di ricevere la comunione, mi riuscì di darle il pacchetto.
Trascorsi l’intera settimana con l’angoscia, temendo che Giuditta non avesse gradito o che fosse stata scoperta dai genitori. Finalmente la domenica ebbi la certezza che tutto era andato liscio. Giuditta con lo stesso mio stratagemma mi fece scivolare sulla mano un piccolo
involucro, che feci immediatamente scomparire in tasca. All’uscita mi sorrise ancora una volta e si avviò con i suoi genitori. Quella fu l’ultima volta che la vidi. In una minuscola scatola metallica aveva chiuso una ciocca dei suoi biondi capelli, legati da un nastrino rosso. Non immaginate neppure quante volte li baciai e li accarezzai, portandoli delicatamente sul mio viso. Da quel giorno presi l’abitudine al mattino di salutare i capelli biondi, di odorarli appena svegliato e di tenere la preziosa scatola dentro il taschino all’altezza del cuore, dovunque andassi.
L’inverno era finito da poco e già nell’aria si sentiva il vento della guerra imminente. Le trattative, le alleanze, gli incontri diplomatici, fervevano, ma l’incomprensione tra i politici responsabili cresceva con maggiore evidenza. La Prussia ruppe gli indugi dichiarando guerra all’Austria. L’Italia che rivendicava il possesso del Lombardo Veneto, occupato dall’impero austriaco, non poteva tirarsi indietro. E fu la guerra anche per il giovane regno d’Italia. A Firenze, la nuova capitale dove il re, la regina e il parlamento si erano trasferiti da Torino, c’era un grande entusiasmo di popolo. Per la terza volta ci si preparava ad affrontare il secolare nemico: l’Austria. In poche settimane l’Accademia si svuotò. Coloro che avevano terminato i corsi furono inviati nella zona di guerra e assegnati ai vari comandi.
A metà giugno del 1866, il nostro esercito, diviso in due armate, è schierato dietro l’Adige e attende il segnale di inizio delle ostilità. Partecipa alla guerra anche il Principe ereditario Umberto, che viene inquadrato nel corpo d’armata al comando di Alfonso La Marmora. Io, forse per una segnalazione della mia famiglia andata a buon fine, vengo assegnato alle dipendenze del Principe, che era quasi mio coetaneo. In soli due giorni, 23 e 24 giugno, si decisero le sorti della guerra. Attraversato il Mincio, le nostre truppe si scontrarono con gli austriaci a Custoza. Pur nelle retrovie, una granata colpì la baracca di legno dove il Principe Umberto con una decina di ufficiali discuteva di strategia. Io ero con loro. Una o due schegge mi colpirono e svenni.
-“Ehi, ragazzo, svegliati, così mi parlava un infermiere accanto a me, sei stato fortunato. Ecco la scatoletta che ti ha salvato la vita!”
Mi mise in mano un piccolo pezzo di metallo quasi informe, che riconobbi subito e lo portati alle labbra. Il Principe era incolume, ma alcuni ufficiali erano stati colpiti a morte. Fu una giornata tristissima per la patria. Quel giorno promisi a me stesso che avrei dedicato tutte le mie forze a scrivere per sollevare il morale dei soldati, per far crescere la
stima e l’onore di coloro che lottano, difendono e muoiono per l’Italia. Il popolo doveva conoscere gli atti di eroismo, i sacrifici, le sofferenze dei soldati in guerra e in pace. Iniziò così la mia carriera di giornalista e di scrittore. I miei articoli sul giornale L’Italia militare riscuotevano un grande successo presso l’esercito e il Ministero della Guerra. Il mio obiettivo principale era quello di esaltare la figura del soldato, di far amare l’esercito a un popolo che di italiano aveva in quegli anni solo il nome, perché formato da gente appartenente a ex regni, granducati, ducati e repubbliche. Far amare un esercito costituito da soldati che con la leva militare provenivano da tutte le regioni, dal nord al sud, fu per me un dovere di estrema importanza. Così andavo alla ricerca di episodi straordinari in cui protagonisti fossero soldati e militari di ogni arma e li raccontavo con semplicità e passione, facendo appello ai sentimenti che il popolo apprezzava di più: il senso dell’onore, l’eroismo, la solidarietà, la pietà, il coraggio, la perseveranza, l’onestà. La gran parte di questi racconti furono raccolti nel volume pubblicato con il titolo La vita militare. Questa attività mi tenne occupato per oltre un anno.
Non avevo dimenticato la bionda Giuditta, la ragazza in fondo mi aveva salvato la vita. E non vedevo l’ora di andare a Modena per incontrarla e ringraziarla. In città, mi recai dunque allo studio fotografico Sorgato per chiedere notizie. Non potevo immaginare che qualcosa di vero di ciò che avevo raccontato in L’esercito italiano durante il colera del 1867 potesse riguardare direttamente la mia vita. Sorgato mi disse che in città si era diffusa la voce che la madre e la figlia, allo scoppio del colera, erano partite verso il sud in aiuto di quella gente sfortunata, ma non erano più tornate. Quella notizia mi sconvolse e mi fece soffrire in modo indicibile. Ancora oggi ricordo Giuditta come colei che è stata per me la ianua amoris. Quella bella bionda ragazza mi socchiuse la porta dell’amore e la mia vita prese un corso diverso, più tenero e caldo, rispetto a prima. Capivo che quelle idee, quei valori che impetuosamente riempivano la mia vita dovevano trasformarsi in sentimenti appassionati e sinceri che, simili a sangue che scorre nelle arterie, dovevano giungere al cuore che tutto accoglie: piaceri e dolori. Ma già qualche critico malevolo faceva sentire la sua voce e mi accusava di creare personaggi lontano dalla realtà, perché aureolati, racchiusi in una sfera inattaccabile di bontà perenne e assoluta e altri personaggi altrettanto rigidi e immutabili ma
orientati al male e alla cattiveria. Questa scelta era da me fatta con consapevolezza proprio perché intendevo far brillare meglio il bene e farlo amare, rispetto a tutto ciò che invece è malvagio e portatore di lacrime e sofferenze. Peraltro c’era anche chi aggiungeva che in molti casi gli esempi positivi di bontà, di dolcezza, di cuore, sfiorassero il grottesco, magari citando quel mio racconto Una morte sul campo, nel quale un padre gravemente malato, appreso il gesto eroico del figlio che muore baciando e abbracciando la bocca del cannone, salvato dalle mani dei nemici con sforzi sovrumani, vuole anch’egli ripetere quel gesto e bacia il cannone. Ebbene, io non trovo nulla di falso, patetico e grottesco in questo comportamento del padre. Una intuizione sentimentale della condotta umana non è stata sempre quella di conferire alla materia, parte della nostra anima? Non siamo stati sempre pronti a bagnare con le nostre lacrime la pietra sulla quale ha posato per l’ultima volta il capo la nostra amata, la madre, il padre, il figlio? Non abbiamo sempre venerato quell’oggetto che chi ci ha lasciato per sempre usava tenere sempre con sé? Non lo abbiamo custodito con cura, quasi come se contenesse anch’esso un po’ di quella vita scomparsa? Non abbiamo sempre visitato con commozione straordinaria il luogo esatto dove ha lasciato la vita un nostro caro, magari illuminandolo con un cero, adornandolo con una targa o qualcosa di simile? E’ ciò che in realtà ha sempre fatto l’uomo nella sua millenaria storia. Perché dunque meravigliarsi di un sentimento identico rappresentato in un racconto, bollato prontamente come grottesco e ridicolo. Quell’anziano padre abbraccia e bacia la bocca del cannone, così come ha fatto il figlio un istante prima di morire, perché crede che quel duro metallo abbia succhiato e imprigionato una piccola parte dell’anima del figlio. E dunque quel gesto è un simbolo di amore e di assoluta dolorosa dignità.
Comunque la mia carriera di giornalista e scrittore proseguiva con successo. I miei editori mi consentivano di viaggiare per tutta l’Europa e anche oltre. E per ognuno di questi viaggi nacque un libro che fu accolto dal pubblico con grande interesse: Spagna, Olanda, Londra, Marocco, Costantinopoli, Parigi.
Fino a quel momento ogni mio articolo, ogni mio libro, era conosciuto sull’onda di un prorompente entusiasmo per la patria da poco formatasi, da un fermo desiderio di riscatto del popolo mediante la lotta
all’analfabetismo, all’ignoranza e alla superstizione. Avevo seguito l’esercito italiano e raccontato quel che passava sotto i miei occhi. A Porta Pia qualche cannonata sbrecciò le mura della città e, dopo aver raccolto i nostri morti, entrammo senza ulteriore indugio e senza chiedere permesso al Papa Re!
Furono giorni indimenticabili. I soldati si sparpagliarono a squadre lungo le vie della città, dapprima sospettosi e guardinghi, poi man mano che passavano le ore sempre più sicuri. Io mi ero aggregato a una squadra di una decina di soldati al comando di un giovane tenente e non mi stancavo di guardare i palazzi e i monumenti che scorrevano dinanzi ai miei occhi. Ero colpito dal numero straordinario di fontane, l’acqua scorreva in abbondanza da tutte le parti. A un certo punto qualcuno disse al tenente se potevamo fermarci a bere presso una piccola fontana dove l’acqua scorreva da un tubo a becco. Aveva appena finito di bere per primo il signor tenente, quando un oste con un berretto in testa e un grembiule si affacciò alla porta della sua bottega e con un vocione nasale disse: “Aho, sor tenente, ma che fa? Ve bevete l’acqua der Tevere? Ma ve fa male! Venite, venite dentro co la truppa; Sua Santità, er papa e urtimo re de Roma, vi offre a gratise un ber bicchiere de rosso”.
L’oste, allegro e loquace brindò alla salute di re Vittorio e di quei primi soldati italiani. C’erano tante cose da vedere nella città, che l’imperatore Adriano per primo chiamò eterna, ma “Nun ve scordate, raccomandò ilsimpatico oste, d’annavve a legge le pasquinate appese ar busto de Pasquino ne li pressi de Piazza Navona. Così potete conosce mejo li fatti belli e brutti de Roma mia”. E vedendo che ogni tanto il tenente si toccava la pancia, mentre i soldati salutavano e uscivano, l’oste ridendo gridò: Aho, sor tenente, stavo a scherzà; quella nun è acqua der Tevere, ma acqua Marcia, bona e salutare!”
Poco tempo prima di partire per il Marocco, mi decisi a sposare, ma solamente in chiesa per le ripetute perplessità della mia famiglia, Teresa Boassi, una donna più anziana di me di qualche anno, non priva di un certo fascino, ma di modeste condizioni economiche. Il ricordo di Giuditta continuava a sovrastarmi e già al ritorno dal Marocco, mi accorsi che era scemata alquanto quella prima infatuazione e che forse avesse ragione mia madre.
Con la pubblicazione di Cuore avevo raggiunto quella fama cui da sempre aspiravo. Le edizioni che si susseguivano a ritmo serrato, le
richieste di traduzioni che pervenivano dai più diversi e lontani paesi, mi davano una vertigine di piacere, mi esaltavano al punto da trascurare i miei doveri familiari e da dimenticare le noie della vita quotidiana. Passavo la maggior parte del mio tempo a casa della mia Teresa, mia madre, che non in quella dell’altra Teresa, che non amavo più da tempo ormai. Non c’era più in lei traccia dell’antica bellezza e del fascino che da giovane mi avevano colpito. Ora la chiamavo “megera scellerata”. Le liti si moltiplicavano di giorno in giorno, le grida arrivavano fin sulla strada. Tra i motivi delle nostre violente baruffe non c’erano solo banalità, ma anche accuse nei miei confronti che io sentivo di non meritare.
-“Quel povero ragazzo, tu lo trascuri. Non mi importa che tu non hai più affetto alcuno per me, ma per il nostro Furio hai il dovere di fare qualcosa. Non vedi che in questi ultimi mesi si è lasciato andare, non frequenta più i suoi amici. La sera lo sento spesso piangere nella sua camera. Perché ti rifiuti di aiutarlo? Ha una grande sensibilità, è dolce e delicato nel suo comportamento; ha la segreta speranza di ottenere quel successo che tu hai raggiunto”.
-“Non è facile. Io non so ancora se possiede il talento necessario. Gli ho suggerito di dedicarsi alla medicina. Potrà seguire i corsi all’università come tanti altri giovani promettenti. Per questo non gli mancherà tutto il mio appoggio”.
-“Sono sicura che tu soffri di gelosia. L’idea di un altro De Amicis in letteratura ti darebbe fastidio. Ammettilo! Mi hanno riferito che tu gli intralci la strada tramite le tue conoscenze. Furio si è visto rifiutare poesie e racconti senza alcuna spiegazione, se non quella di dire che i progetti di stampa sono al completo”.
A questo punto mi innervosisco e, alzando la voce, lancio per terra la borsa che tenevo in mano e vola qualche parola grossa. Poi, riacquistata un po’ di calma, cerco di chiudere la discussione: “Già da qualche tempo, quando Furio non era in casa, sono andato più volte nella sua camera e ho sbirciato tra i suoi scritti. Ma non una volta ho riscontrato qualcosa che meritasse di essere stampato. Spesso l’errore più grave che un genitore possa fare è quello di voler coltivare a ogni costo una qualità che il figlio non possiede, magari trascurando ciò che invece possiede. E io non intendo fare questo errore!”
Fine Prima Puntata
La seconda e ultima puntata sarà pubblicata il prossimo 31 maggio.