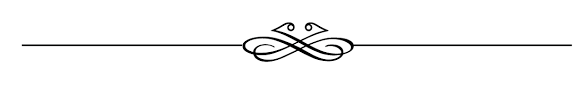Ora et Labora: un monaco ci salverà … (forse)

Di Gianvito Pipitone

Aveva ragione probabilmente quel tale che, durante il periodo più nero della parabola pandemica, quando ci ritrovammo increduli e sgomenti seppelliti vivi in casa, nonostante fossimo tutti presi dall’emotività del momento, nemmeno in quel drammatico frangente si lasciò infinocchiare dal flusso di dilagante ipocrisia. “L’essere umano ne uscirà più forte di prima”. “Quando tutto sarà finito, l’uomo avrà imparato le cose importanti della vita, quelle che contano veramente”. E cose così, più o meno imbarazzanti.
E a chi andava sciorinandogli, con le lacrime agli occhi, dei propositi di vita futuri e dei progetti di grande cambiamento per le magnifiche sorti e progressive, una volta che “lo grande morbo” fosse stato debellato, lui opponeva la sua fredda versione dei fatti, se si vuole “cinica”, ma pur sempre lucida, spesso accompagnata da una robusta scrollata di spalle. Non credo che il Nostro caro e affezionatissimo fosse particolarmente affetto da pessimismo cosmico, né che ci tenesse particolarmente a passare per bastiancontrario o menagramo del caso. Immagino che non solesse consultare né una sfera di vetro e neppure la cabala quando alla domanda sul suo atteggiamento “distaccato e pessimista”, di solito affermava con estrema serenità: “semplicemente penso che non andrà tutto bene se andrà tutto come prima”.
Recentemente mi sono imbattuto per caso in Alasdair MacIntyre, figura di spicco della filosofia contemporanea e, senza avere tempo di approfondire il suo sterminato pensiero, mi sono concentrato sull’interessante parallelismo che il filosofo scozzese fa fra il Tardo Impero Romano (all’incrocio con l’inizio dell’alto Medioevo) e la congiuntura storica Contemporanea.
MacIntyre parte da una dura critica della modernità post-illuministica che, a suo parere, “ha lasciato l’uomo preda di un soggettivismo emotivistico e di un relativismo individualistico”. Proprio a causa di ciò – prosegue MacIntyre – “la nostra è (diventata) un’epoca di decadenza, simile a quella della caduta dell’impero Romano: come allora, necessaria e oltremodo salutare si rivelerebbe l’opera di un nuovo san Benedetto, capace di rifondare il tessuto morale della società in nome di un’etica della virtù basata su valori religiosi e comunitari”.
Secondo il filosofo scozzese, insomma, la situazione che stiamo vivendo adesso, mutatis mutandis, assomiglierebbe né più né meno a quella dei secoli bui del declino dell’impero romano (400-500 d.c.) in cui a causa di una profonda crisi economica, culturale oltre che morale si produsse una scintilla che sembrò portare ad un uomo nuovo.
Fu in quel contesto che figure come San Benedetto, spesso senza rendersi conto pienamente di ciò che stavano facendo, iniziarono a costruire nuove forme di comunità in cui una nuova civiltà e una nuova morale avessero la possibilità di sopravvivere all’incipiente epoca di barbarie e di oscurità che si stava preparando a vivere il mondo.
Ora, immagino che il parallelismo proposto dal MacIntyre non vada inteso alla lettera e che figure come San Benedetto da Norcia al giorno d’oggi, seppur presenti sotto mentite spoglia nelle strade, nelle università, nelle scuole, nelle chiese e, in potenza anche nelle istituzioni, registrino una fatica immane per stare al passo con la realtà mutevole, sfuggente e iper competitiva del tempo presente.
Mi sembra evidente che l’appello del filosofo scozzese suoni più che altro come un accorato auspicio a ritrovare la via smarrita in questi tempi di “tardo impero contemporaneo” riparametrando tutto dal grado zero per ripartire con la creazione di un Uomo Nuovo.
Volendo però rimanere aderenti all’interpretazione più letterale, è interessante cercare, nelle pieghe del monachesimo benedettino e del suo fondatore, la chiave di volta che dovrebbe dare accesso a questo tipo di uomo nuovo di cui parla MacIntyre. Quali dunque le sue caratteristiche, le sue virtù e quale la sua indole per poter creare un contesto (o dei contesti) nuovi per l’umanità?
La storia della civiltà occidentale deve moltissimo al monachesimo. Sin dalla nascita dell’Ordine benedettino, i monaci di Montecassino furono gli unici nei secoli difficili dell’Alto Medioevo a preservare, attraverso gli scriptoria dei vari monasteri, il sapere dei grandi classici latini e greci. Senza la paziente opera di copiatura e miniatura dei monaci oggi non sapremmo nulla di Cicerone e Seneca, di Virgilio e Lucrezio. La stessa concezione (e coscienza) del mondo occidentale così com’è ora, sarebbe di certo diversa senza l’adamantino lavoro di questi “pazienti copisti e fulgidi amanuensi” che hanno così sfidato (vincendola) la battaglia contro la furia distruttrice dei barbari invasori. Conservare e avere cura delle cose importanti in nostro possesso, potrebbe dunque essere fra i primi compiti dell’uomo nuovo.
Ma, a parte l’aver permesso alla posterità di trasmettere la cultura e il sapere degli antichi classici (cosa già di per sè di inestimabile valore) in che cosa consisteva il monachesimo e quale il suo valore intrinseco? Per rispondere a questa domanda, fa al nostro caso una felice definizione del prof. Vito Fumagalli (1938-1997) direttore del dipartimento di Medievistica dell’Univ. di Bologna: “direi che (il monachesimo) in tutti i tempi è stato ed è la riflessione presa a distanza di un mondo in gravi crisi, come accadde nei primi secoli di diffusione del fenomeno monastico. Il monachesimo è un richiamo potente ad alzare il tono e la tensione della vita morale e spirituale. Come ce ne fu bisogno in quei secoli lontani di caduta dei sistemi di valori, così ce ne è bisogno oggi. L’antidoto fondamentale del monachesimo contro la crisi, è la solidarietà. La solidarietà infatti, che è insita nell’anima monastica, si oppone alla solitudine, al chiudersi degli uomini in sé stessi, all’isolamento reciproco, all’indifferenza, spesso alla guerra e all’odio. Il monachesimo forniva l’esempio e la predicazione della comunione e della compartecipazione, vivendo in comune e studiando in comune, cercando mete lontane in comune”. Non ci può essere definizione migliore, a mio avviso, per centrare in pieno la tesi del parallelismo di MacIntyre.
E, in definitiva, per quale motivo oggi la riscoperta del monastero e delle sue regole possa fungere da guida per una via alternativa alla costruzione di un uomo nuovo? Forse perché il monastero rappresentò per lunghi secoli un magnifico polo di attrazione incorporandosi con tutto il suo potenziale di virtù umane, nel flusso del mondo, svolgendo una grandiosa azione economica, sociale, culturale, che fece dei Benedettini i maestri e gli agricoltori d’Europa e trasformandosi all’occorrenza in banca, laboratorio, azienda agricola, scuola, biblioteca.
Un altro merito che gli va riconosciuto è quello di essere rimasto quasi sempre indipendente dalle scelte e dall’ingerenza della Chiesa rappresentando per essa “una riserva delle buone energie nelle ore di smarrimento e di battaglia”.
E al giorno d’oggi dunque? a quale monastero votarsi e dove cercare focolai di speranza in mezzo al mare magnum dell’indifferenza? del relativismo individualistico o del soggettivismo emotivistico, per dirla alla MacIntyre. Domanda da un milione di dollari.
Un uomo nuovo, che abbia finalmente smesso di gravitare egoisticamente su sé stesso e attorno al proprio io per meglio identificarsi con la sua comunità e con i bisogni collettivi, non è di certo un approdo semplice da raggiungere. Tuttavia, in ogni tempo, non escluso il nostro, la società ha proposto ideali che aiutassero l’uomo a sollevarsi dalla miseria e dalla bassezza che spesso il vivere in società comporta. Il Mahatma Ghandi, il Dalai Lama piuttosto che Martin Luther King sono solo alcuni fra questi esempi e modelli positivi da tenere in considerazione nell’ultimo secolo. La virtù umana non ha religione, lo sappiamo: solo regole da rispettare. Lo stesso Papa Francesco, per fare un altro esempio, sembrerebbe probabilmente incarnare quella figura contemporanea vicina a San Benedetto, di cui parlava MacIntyre.
Ma purtroppo gli “esempi” non sembrano bastare più di questi tempi. E qualsiasi aspetto del nostro vivere (argomenti, istituzioni, idee, persone, modelli e società) sembra diventato irrimediabilmente oggetto di profonda divisione e di cieco fanatismo fra gli uomini. Un aspetto per nulla secondario con cui si dovrà fare i conti d’ora in avanti. No Putin / Pro Putin è solo l’ultima in ordine di tempo, delle categorie dicotomiche in cui gli uomini si vanno dividendo, asserragliati gli uni e gli altri dietro ad un’invalicabile certezza, a dispetto persino di prove empiriche.
Il sospetto è che forse abbiamo buttato alle ortiche un’occasione d’oro durante questa parabola pandemica, quando lo spirito di ognuno di noi era più incline all’ascolto e alla riflessione, meno carico di sovrastrutture e più ben disposto alla solidarietà. Lì, in quello spazio preciso, che ognuno di noi conosce bene, si sarebbero potute gettare le basi per un uomo nuovo. Lì, ognuno di noi avrebbe potuto e dovuto prevedere di costruire un’alternativa, un nuovo modo di essere e di rapportarsi agli altri. Ma non ha funzionato. La sensazione, come si diceva all’inizio di questa riflessione, pare invece di tutt’altro segno. In questo spazio potenziale sembra siano ritornati prepotentemente per restarci a lungo vecchi fantasmi e cattivi maestri. E davanti alle bombe russe in Ucraina, nemmeno San Benedetto sembra poterci fare più nulla. Con buona pace del filosofo.
Sic transit gloria mundi.