“Lessico Siciliano” di Vincenzo Fiaschitello – seconda parte
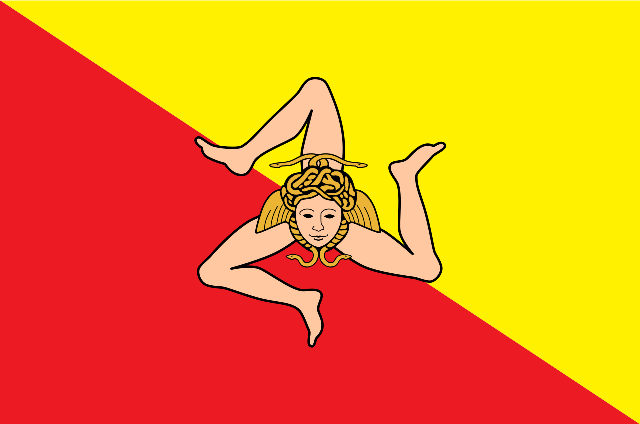
Lessico siciliano-
LESSICO SICILIANO – Parte seconda
6- Non scherzare con i santi
Nun na babbiari che santi
Non scherzare con i santi
Espressione ben nota e diffusa in tutta la penisola. In Sicilia probabilmente è legata alla rivalità quasi sempre molto accesa originata dalla venerazione per i santi protettori di due paesi confinanti o addirittura di due quartieri dello stesso paese. Più che una forma di bestemmia, possiamo immaginare una irriverenza nei confronti del santo “avversario” e della modalità dei festeggiamenti e dei comportamenti dei fedeli.
Gli anziani raccontavano che al tempo della loro fanciullezza, il quartiere che festeggiava San Giuseppe era in guerra permanente con l’altro che aveva per protettore San Guglielmo.
Quando la rivalità non degenerava in furibonde risse, magari anche con qualche poveretto accoltellato che restava a terra sanguinante, gli scherzi, i fischi, erano del tutto normali. Per tale motivo si studiavano attentamente i percorsi che il Santo doveva compiere in processione, ma ciò nonostante gli scontri erano inevitabili.
In quel clima scherzare anche pesantemente sul Santo avversario era il minimo che ci si potesse attendere. Nei bar, nelle osterie, per le strade, quando un giuseppino si incontrava con un gugliemino non c’era scampo.
I giuseppini non potevano dimenticare la più grave delle irriverenze nei confronti del loro Santo ad opera dei gugliemini. La festa di San Giuseppe si concludeva la sera tardi con il sorteggio di un numero incredibile di dolci offerti dai fedeli.
Accadde un anno che tra questi dolci ne capitò uno che era stato confezionato con ricotta fresca, mista a escrementi di pecora.
Si gridò alla scandalo quando si seppe del fatto, ma anche alla vendetta.
E la vendetta venne puntuale qualche settimana dopo!
I gugliemini, portando in processione San Guglielmo, si ritrovarono ad un certo punto con il Santo che rotolava lungo una scalinata. Durante la notte qualcuno si era introdotto in chiesa e segretamente aveva segato quasi completamente uno dei quattro assi di legno che i portatori della statua appoggiavano sulla spalla.
San Guglielmo si ruppe un braccio e perse un grosso anello d’oro con rubino che non fu mai più ritrovato.
Molti anni dopo, nel paese dove abitavo da ragazzo succedevano ancora avvenimenti che si potevano collegare a quegli antichi comportamenti.
I fedeli erano contrari a che il Santo Patrono uscisse in “missione”, così come aveva deliberato la Curia vescovile. Il Santo doveva essere condotto nella vicina città per ricevere onori e devozione come era stato richiesto da quella gente.
Il giorno stabilito, il clero in processione accompagnò il Santo fino all’uscita del paese. Ma lì una folla minacciosa costrinse vescovo, parroci e chierici e i pochi fedeli consenzienti a tornare indietro precipitosamente.
Fu durante quella storica ritirata che il vescovo cadde malamente e si ferì in modo serio. Tutti gridarono al miracolo: San Giorgio aveva con ciò dimostrato che non voleva andare, appunto, a far visita alla protettrice della città avversaria.
Del resto anche fra noi ragazzi c’era un modo per sopravvalutare un Santo e screditarne un altro. In un tempo in cui non possedendo neanche uno spicciolo, si giocava con i santini. Esisteva una specie di borsa: tante figurine di San Giuseppe per una di San Guglielmo, tante di Santa Lucia per una di San Girolamo.
Le nostre opinioni in merito evidentemente rispecchiavano le idee degli adulti circa il grado di venerabilità e quindi l’importanza di un Santo.
Il più delle volte, dunque, restava inascoltata la raccomandazione: nun na babbiari che santi!
7- Da dove vieni
Runni vieni? Viegnu ri nu paisieddu unni l’acqua si cerni cu lu crivu.
Da dove vieni? Vengo da un paesino dove l’acqua si raccoglie con il crivello.
Dove sarà stato mai un tal paesino, nessuno poteva dirlo. Tranne don Nanè.
Era questi un mendicante che la domenica mattina se ne stava davanti la chiesa del Carmine dall’ora della prima messa per coloro che per abitudine erano costretti ad alzarsi presto, fino all’ultima messa di mezzogiorno.
Aveva sempre un sorriso gentile per tutti, sia che ricevesse l’elemosina, sia che non venisse degnato neanche di uno sguardo. Pur se mendicava non era affatto sporco o malmesso. D’estate portava camicia e pantaloni molto rattoppati e ai piedi sandali legati con uno spago. D’inverno lo si vedeva con un lungo cappotto verde scolorito con due o tre toppe di stoffa di colore diverso e in testa un tasco con la visiera, che ogni volta che passava qualcuno, fosse anche un ragazzo, si toglieva rispettosamente.
Piccolo di statura, aveva un viso rotondo e due occhi scuri che lasciavano intravedere una mansuetudine naturale.
Negli altri giorni percorreva itinerari fissi in modo tale che una volta a settimana bussava alla porta di tutte le case del paese. Quando gli si chiedeva perché continuasse a bussare dove ormai sapeva che non riceveva nulla, egli rispondeva tranquillamente che non poteva fare uno sgarbo e non dare il suo saluto.
Aveva ragione. Con gli anni anche quelli più duri di cuore un po’ alla volta si erano lasciati addolcire dai modi gentili e dai discorsi che faceva don Nanè e davano qualcosa volentieri.
Così don Nanè non pativa la fame e aveva anche un buon rifugio. Un contadino gli aveva concesso di dormire in una piccola stanza a piano terra, che un tempo veniva usata come stalla. Vi aveva sistemato tutto ciò che gli serviva, poche cose anch’esse frutto di generose donazioni.
Spesso lo seguiva nelle sue peregrinazioni un piccolo gruppo di ragazzi che amavano ascoltare le sue storie. Una in particolare li attraeva. E don Nanè non si faceva poi pregare troppo per raccontarla.
In un paese non molto distante da lì (ma non precisava mai quale!), viveva un tale di nome Giuseppe. La vita era molto dura: nonostante lavorasse dal mattino alla sera riusciva a malapena a mettere in pentola qualcosa per sé e la sua famiglia.
Quando morì San Pietro lo accolse e, dimostrando di conoscere non solo le lingue nazionali, ma anche i dialetti, gli domandò: ”Runni vieni?”
Giuseppe non meravigliandosi affatto gli rispose con naturalezza: “Viegnu ri nu paisieddu unni l’acqua si cerni cu lu crivu!”
A quel punto San Pietro gli sorrise e lo fece entrare in Paradiso.
La storia in sé era molto semplice, ma don Nanè la raccontava con un’aria ispirata, come fosse un profeta, aggiungendo ogni volta sempre nuovi particolari, tanto che qualche ragazzo ribatteva: “Ma, don Nanè, non ti ricordi che l’altra volta hai detto che Giuseppe quando salì in cielo era tutto vestito e aveva anche le scarpe nuove?”
-“Sì, certo, ma giunto alla presenza di San Pietro, Giuseppe è ormai un’anima e non ha più nulla addosso!” rimediava così don Nanè.
Ciò che però non cambiava mai era il significato della storia. San Pietro apre le porte del Paradiso a Giuseppe, perché chiunque venisse da quel paese dove tutto costava enorme fatica, persino la raccolta dell’acqua che, facendosi con un crivello, non poteva che essere pressoché impossibile, meritava il premio finale.
Quel pomeriggio d’inverno, quando qualcuno trovò in un fosso don Nanè, irrigidito dal freddo, certamente si era già verificato l’incontro in cielo con San Pietro che gli chiedeva: “Runni vieni?”
E don Nanè sapeva come rispondere!
8- Si inghiottì tutto
Si agghiuttiu tuttu comu nu lofiu o allamatu
Si inghiottì tutto come un insaziabile, un affamato.
Lofiu è colui che non sa darsi una regola, un contegno nella consumazione del cibo. E’ colui che manda giù in fretta senza assaporare, per rimpinzarsi.
Naturalmente chi era ritenuto lofiu veniva guardato a vista, poteva non essere mai più invitato ad un banchetto e comunque non lo si lasciava servire da solo.
Oggi che si naviga nell’abbondanza si stenta a credere che soltanto alcuni decenni fa si potessero attribuire giudizi così severi a difetti simili. Ma allora era veramente difficile non essere lofiu. Ciascuno si portava dietro secoli di povertà, di astinenza forzata, di digiuni piuttosto prolungati, di sogni di cibi raffinati e di dolci.
Quando si aveva la fortuna di essere invitati ad una festa dove si elargiva a profusione ogni ben di Dio, come si faceva a non essere lofiu? Si mangiava tutto anche a rischio di scoppiare!
Probabilmente oggi l’espressione può conservare tutta la sua valenza se riferita al pubblico amministratore corrotto o all’uomo politico.
L’insaziabilità di alcuni di loro nell’accumulare tangenti e mazzette rende perfettamente l’idea dell’inghiottire tutto ciò che è possibile come un lofiu, fino al completo esaurimento del pubblico denaro.
9- Vi inzuppò il pane
U pani ci assuppau
Vi inzuppò il pane.
Si dice di chi, fingendo di voler venire in soccorso del prossimo, vuole conoscere ogni particolare di un avvenimento e si dimostra generoso in consigli poco disinteressati e in raccomandazioni ironiche.
La rivelazione di una confidenza per qualcuno si trasformava in un fatto così gustoso quale poteva essere l’inzuppare il pane nel latte o in un sugo. Questo gesto dell’inzuppare per me è legato a due fatti: il primo piacevole, il secondo tragico.
La casamatta costruita sul terreno dei miei nonni (ancora oggi esistente) era una delle tante che furono predisposte nel triangolo sudorientale della Sicilia, per impedire lo sbarco degli alleati anglo americani. Com’è noto, fu tutto inutile.
Abbandonata, io e mio cugino, dopo cinque o sei estati dal famoso luglio del 1943, l’avevamo adottata come luogo dei nostri giochi.
Da lì, sorvegliavamo la capra che il nonno ci affidava, tutti i giorni verso il tramonto, prima della mungitura.
Quel giorno il pranzo non era stato sufficiente. Mio cugino era riuscito a nascondersi in tasca un bel pezzo di pane e fischiettava tirando la capra, che ad ogni passo voleva fermarsi per brucare l’erba fresca.
Giunti alla casamatta, legò la capra ad un ulivo dicendomi: “E’ il momento di mangiare!”
Pensavo che si riferisse al pane e già mi accingevo a riceverne una metà. Invece tirò fuori una ciotola, si chinò fino a terra e afferrando le mammelle della capra cominciò a mungere gridando di aiutarlo.
La gran parte del latte finiva a terra, ma dopo un po’ la ciotola fu quasi piena. Poi mi invitò ad allontanarmi e, stendendosi completamente sotto la capra, continuò a mungere innaffiandosi dappertutto.
Non so quanto tempo durò, ma quando venne fuori era zuppo di schiuma bianca di latte e sorridente. Nel frattempo avevo tagliato il pane a piccole fette e lo avevo inzuppato nel latte: “Mangialo tu, io non ne voglio!” mi disse e si mise a gironzolare attorno alla capra.
Non ho mai più ritrovato un sapore così gustoso in una zuppa di latte!
In paese tutti conoscevano don Salvatore, un uomo sulla quarantina che viveva solo in una piccola casa circondata da un giardino, dove un cane bastardo gli teneva compagnia.
La casa sorgeva sulla strada provinciale, all’ingresso del paese, per cui passando di là al ritorno dal lavoro ognuno si fermava e scambiava volentieri qualche chiacchiera.
Così don Salvatore, con la simpatia e la cortesia, era riuscito a sapere tutto di tutti. Il guaio era che non sapeva serbare per sé le confidenze.
–U pani ci assuppau, -così andavano dicendo coloro che avevano ricevuto qualche segno di scarso rispetto.
Finì che un giorno, un povero diavolo, che gli aveva confidato il tradimento della moglie e che per questo si era visto dileggiato dai paesani in più di una occasione, giurò di vendicarsi.
Una sera di ottobre, don Salvatore fu visto nella abituale posizione accanto all’uscio di casa. Nella penombra ormai avanzata qualcuno, avendolo salutato senza ricevere risposta, aveva scoperto il delitto.
Don Salvatore era morto così come era vissuto. Teneva ancora tra le mani un pezzo di pane e un piatto sulle ginocchia. Inzuppava il pane nel sugo del suo sangue, che scendeva ancora dalla sua gola squarciata.
In un angolo giaceva il cane che aveva subito la stessa sorte.
10- Il mento
U babbuottu
Il mento e, per assimilazione, anche la barba, il pizzetto.
Sin dai tempi più antichi, com’è noto, la barba è stata sempre un segno di prestigio, di autorità.
Anche fuori della scuola, tutti noi studenti avevamo una certa soggezione del professore di filosofia. Bastava che qualcuno di noi, mentre la sera passeggiavamo per il corso discutendo animatamente, lanciasse l’allarme:”U babbuottu!” per bloccarci e perdere la nostra spontaneità e allegria. Gli si indirizzava in coro un “buonasera professore”, che valeva più di un “attenti” con relativo colpo di tacchi dinanzi ad un colonnello.
Non si fermava mai a parlare, né tantomeno noi l’avremmo desiderato. Restava l’ansia per la mattina seguente, allorché si sarebbe ricordato delle nostre facce e avrebbe provato a verificare se il giorno prima non avessimo per caso trascurato di studiare.
A nulla servivano i nostri tentativi di fargli perdere del tempo prezioso con le più assurde domande di attualità, alle quali rispondeva molto volentieri e saggiamente. Ma il tempo per lui era sempre più che sufficiente!
-“Bene, fermati là!” – era questo il momento cruciale della interrogazione, perché dopo una breve esposizione senza alcuna interruzione, poneva alcuni quesiti per saggiare la capacità di comprensione e di logica.
U babbuottu, poi, cominciava a passeggiare su e giù, gesticolava, si poneva domande, rispondeva, si fermava, ricominciava a camminare, si puliva gli occhiali, si lisciava la barba, ci guardava severamente.
L’imperativo categorico kantiano gli dava lo spunto per sottolineare i doveri della vita, il rigore morale, la razionalità in contrapposizione alla vita istintiva.
Quelle parole toccavano la mente, un po’ meno il cuore! Erano gli anni della spensieratezza, della gioia, del sorriso, dietro ad ogni angolo.
La severità della vita poteva aspettare!
Ci chiedevamo come e perché si fosse fatta crescere la barba. Ci piaceva credere alla storia che la barba gli servisse a nascondere una brutta ferita sul mento che risaliva al tempo della guerra.
Più tardi chi di noi, ormai adulto, l’ha potuto avvicinare amichevolmente, ha appreso che non era vera la storia.
Ben altre ferite, tuttavia, la vita gli aveva riservate. Sapendolo perfetto ateo, allora, non ci aveva sorpreso il nome che aveva imposto al suo unico figlio.
Ora la solitudine, dopo la morte di Ario per un incidente d’auto, gli pesava terribilmente!
Non minore autorità la barba esprimeva se apparteneva a un monaco.
Quella dei monaci era diventata provvidenziale per coloro che, alle domande sull’arte gotica che l’architetto con ossessiva frequenza poneva, restavano imbambolati non riuscendo a spiccicare parola. Bastava che suggerissimo:” Quiddi co babbuottu”( Quelli con la barba), e d’un tratto tornavano alla mente i monaci cistercensi che appunto erano celebri per la loro barba.
L’architetto era il nostro professore di storia dell’arte. Piccolo di statura, magro come un chiodo, appena brizzolato nonostante i suoi sessant’anni.
Si vantava di essere il migliore, di saper riconoscere d’istinto un artista. Lui stesso diceva di essere un illustre pittore. Aveva dipinto molti quadri, ma sapevamo che nessuno ne aveva mai acquistato uno.
Tra noi apprezzava soltanto Corrado, tutti gli altri erano per lui degli asini.
Il nostro amico Corrado sapeva come accontentarlo, disegnava secondo i suoi gusti, con tratto sicuro e con i contorni nitidi e precisi nei particolari. Così si era conquistata la sua fiducia. A lui aveva confidato che stava finalmente per ricevere il massimo del riconoscimento con l’allestimento di una mostra della sua ricca collezione. Per questo nei giorni immediatamente precedenti, l’architetto invitò Corrado a casa sua per i lavori di preparazione.
Alla mostra convenne una gran folla da tutti i paesi vicini. Non mancarono i migliori critici e naturalmente anche noi, suoi allievi, andammo ad ammirare i suoi quadri. Un particolare ci colpì subito e suscitò in noi una ilarità irrefrenabile.
Non si fece attendere, la mattina seguente, la stroncatura del novello pittore sulla pagina del giornale locale. Al critico non era sfuggito quello che noi avevamo visto e lo aveva ben rilevato.
Corrado aveva tradito la fiducia del maestro.
In un paio di quadri che avevano per soggetto paesaggi di epoca primitiva aveva semplicemente “aggiunto” sulle palafitte raffigurate qualche antenna per la televisione!
Nell’unico piccolo albergo a conduzione familiare di cui disponeva il paese, Carmelu faceva da portiere, da cameriere, da facchino e da operaio. E’ vero che c’erano appena cinque camere, ma il lavoro non mancava.
Negli ultimi tempi Carmelu aveva dovuto imparare a convivere con i progressi della tecnica. Quando squillava il telefono correva a prendere la cornetta e senza dire nulla attendeva che l’altro parlasse, poi cominciava a sua volta chiedendo e rispondendo in strettissimo dialetto.
Le storie che ci raccontava, quando andavamo a trovarlo la sera mentre se ne stava seduto nel piccolo ingresso dell’albergo, ci divertivano e ci davano il senso di appartenenza alla nostra terra, perché avevano sicuramente solcato le strade di una cultura antica costruita dai nostri vecchi.
Aveva il prestigio di un affabulatore e lui se ne rendeva conto. Eravamo presi dalla sua voce che sapeva modulare a seconda degli avvenimenti, affascinati da parole che ormai neanche i nostri genitori usavano perché tramontate. Nella sua bocca quelle storie diventavano miniminagghie, cioè storie esemplari, proverbi, indovinelli.
Ne rammento ancora qualcuna.
Al tempo della transumanza, i paesani si divertivano ad indovinare il nome del pastore che passava con il suo gregge dal suono dei campanacci.
Quando passava il gregge di Campanaccio non si sentiva alcun suono, se non il belato delle pecore. Era il gregge più numeroso. Un giorno finalmente qualcuno volle togliersi la curiosità e gli domandò:
”Ma senti, le tue pecore sembrano tristi, tu perché non appendi nessun campanaccio?”
“Hai ragione, ma vedi il latte me lo fanno lo stesso!”
Spesso ci narrava quella del servitore sempliciotto e del suo padrone senza cervello. Le variazioni erano tante, ma aveva avuto un bel successo quella che finiva con questa battuta: il padrone dice al servo di andare a vedere se è piovuto. Quello non sa come fare. Allora il padrone adirato:”Babbazzu, vai fuori e vedi se il cane è bagnato!”
Un’altra che ascoltavamo volentieri era quella di un uomo che, volendo suicidarsi, si avvicina a un precipizio e si butta giù senza esitare. In fondo, purtroppo, c’era un contadino che ignaro zappava tranquillamente il suo giardino. Gli cade sulla schiena.
Per fortuna i due si salvano. Il contadino però lo cita in giudizio e rivolgendosi al giudice dice: “Eccellenza, mi ha rovinato la vita, adesso ho dolori in tutto il corpo e non posso più lavorare come prima!”
L’accusato si difende: “Io non volevo, non l’ho fatto apposta”
Alla fine il giudice, stanco del dibattito, sentenzia: “Non resta altro che fare una prova!”
Così invita il contadino a salire sul precipizio e il mancato suicida a mettersi sotto in giardino. E rivolto al contadino dice: ”U taliati e mirati”( Lo guardate e prendete la mira).
Il contadino di rimando: “E se poi mi sbaglio?”
Di tanto in tanto Carmelu era costretto ad interrompere la narrazione per correre a sentire qualche cliente che chiamava.
Una sera arrivò in albergo un tale molto elegante, con un pizzetto brizzolato, accompagnato da una bella signora. Si era dovuto accontentare della camera più piccola perché le altre più comode e spaziose erano già occupate.
Ci accingevamo a salutare Carmelu, quando sentimmo squillare il telefono. Come al solito Carmelu alza la cornetta prontamente e attende. Una voce femminile con accento milanese gli chiede notizie di un cliente. Carmelu risponde in dialetto e dopo varie battute si spazientisce perché dall’altro capo la donna non capisce nemmeno una parola.
Ora il dialogo è davvero tra sordi. Udiamo la donna che dice: “Ma non ho mica sbagliato numero? E’ l’Africa?”
Carmelu si sente offeso, poi come per illuminazione si rende conto che vuole sapere proprio del cliente giunto poco prima:
“Ah, ma quiddu co babbuottu? quiddu co babbuottu?”
E la rimprovera perché non si è saputa spiegare bene fin dall’inizio.
A questo punto Carmelu passa la cornetta a un nostro amico. Questi candidamente chiarisce che il signore con il pizzetto appena arrivato, si è già messo a letto con la signora e non può essere disturbato.
Si sente un urlo di rabbia, poi più nulla!







