Lessico Siciliano di Vincenzo Fiaschitello – Prima parte
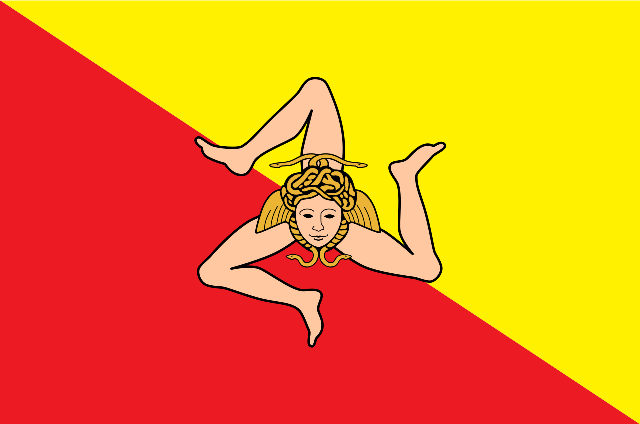
Lessico siciliano-
LESSICO SICILIANO – Prima parte
di Vincenzo Fiaschitello
1-Orecchie tenere
Auricci muoddi ci sunu
Ci sono orecchie tenere. Ci sono cioè persone che per la loro condizione (età, sesso, ecc.) non possono ascoltare certi discorsi.
L’espressione veniva usata per interrompere o camuffare un discorso che non poteva essere portato a conoscenza di un bambino o anche di un estraneo, presenti o improvvisamente intervenuti fra due o più interlocutori.
Ritengo che questo modo di dire, molto popolare negli anni della mia fanciullezza, derivi da una duplice esigenza.
La prima denota certamente una preoccupazione educativa che era viva anche nelle persone dei ceti più bassi: il bambino non poteva partecipare ai discorsi degli adulti, doveva restarsene fuori, soprattutto quando si facevano accenni a temi scabrosi. Vigeva una separazione ben netta tra adulto e bambino anche in un mondo di cultura orale. La sensibilità morale che portava gli adulti, colti o analfabeti, ad interrompere certi argomenti in discussione all’apparire del bambino, si sostituiva al divario adulto-bambino operato di fatto dal testo scritto.
La presenza della cultura televisiva dei nostri giorni impedisce tale distanza. Il linguaggio televisivo è rivolto a tutti, adulti e bambini. Non ci sono auricci muoddi: anche il bambino può ascoltare ciò che ascolta l’adulto!
La seconda esigenza è particolarmente negativa, sorgendo dalla malevolenza, dal desiderio di nascondere conoscenze e fatti o, peggio, dall’omertà. Così ha auricci muoddi la moglie di uno degli interlocutori che incautamente si avvicina al gruppo; ha auricci muoddi chi è conosciuto come spia e a maggior ragione il poliziotto che cerca di indagare.
2- Avviamento professionale
Avviamentu professionali: sceccu trasi e sceccu esci
Avviamento professionale: entri asino e asino esci.
E’ la frase dispregiativa che veniva rivolta a quei ragazzi che per condizione economica o per scarso profitto nello studio erano invitati ad iscriversi all’avviamento professionale, esistente fino al 1962, quando finalmente fu istituita la scuola media unica.
Non era raro il caso che a quell’ordine di studi venisse avviato anche qualche ragazzo intelligente che la famiglia a costo di duri sacrifici intendeva far studiare. La situazione di questi ragazzi era certamente la più difficile.
L’istituto dove era alloggiato l’avviamento stava proprio di fronte alla scuola media. I ragazzi si guardavano in cagnesco: la mattina intorno alle otto, quel tratto di strada dall’una parte e dall’altra si affollava in attesa del suono della campanella, che il più delle volte per molti era una liberazione.
Quando non si lanciavano sassate o non lottavano ferocemente, volavano le parole più fiorite. Naturalmente al centro c’era l’espressione colorita dell’entrare asino e dell’uscire asino da una scuola che non insegnava assolutamente nulla o forse soltanto a dare qualche colpo di zappa sul terreno di proprietà dell’istituto, dove i ragazzi venivano portati per il tirocinio.
Questo della esercitazione con la zappa era quello che più suscitava ilarità per gli studenti di scuola media. Se li immaginavano tutti in fila che, all’ordine dell’insegnante come tanti piccoli schiavi, venivano condotti a zappare un terreno, continuamente lavorato senza mai produrre un filo d’erba.
Tuttavia quelli erano pronti a rinfacciare che erano “pretini”, sempre chini sui banchi, destinati alla miopia e alla scoliosi, intenti a tradurre Fedro o Cesare e incapaci di utilizzare il più semplice degli attrezzi della campagna e degli artigiani.
Saverio frequentava la scuola media con ottimi risultati. Un’estate, però, sperimentò la sua completa incapacità, quando dai nonni, in campagna, provò a rendersi utile durante la mietitura del grano. Non riusciva a legare con il fil di ferro i covoni, né era capace di maneggiare la lunga falce che i contadini con destrezza facevano volare tra le spighe.
Mortificato, si ritirò a riflettere sotto un carrubo. Pensò con invidia ai ragazzi dell’avviamento. Al suo posto certamente avrebbero ben figurato.
Quando in autunno riaprì la scuola, Saverio era intenzionato a fare amicizia con qualcuno di loro, a cui per la verità già qualche tempo prima aveva pensato, perché in più di una occasione gli era parso più disponibile degli altri nei suoi confronti. Si chiamava Carlo.
Una mattina, uscito di casa più presto del solito, si ritrovò dinanzi all’ingresso dell’avviamento quando ancora non c’era nessuno. Senza riflettere entrò, deciso a curiosare entro quel palazzo che un tempo era un convento. A destra e a sinistra si aprivano due corridoi lunghissimi, di fronte una larga scalinata portava al piano superiore; lungo il corridoio di destra, attraverso un arco, si passava in un giardino interno di forma quadrata con alberi di aranci, limoni e mandarini e al centro una piccola fontana zampillante.
Era tutto fiorito e si avvertiva un intenso profumo di zagara. In quel momento Saverio sentì suonare la campanella e contemporaneamente una folta vociante schiera di ragazzi si avventò per il corridoio. Qualcuno aveva saputo della presenza di Saverio, studente di scuola media.
In breve fu scovato nel suo nascondiglio, dietro una siepe, e portato nel corridoio vicino a una finestra. In prima fila a spintonarlo e a minacciarlo c’erano i più temibili dell’istituto: ragazzi grandi e grossi, ma soprattutto uno di cui Saverio aveva sempre avuto timore, un certo Guido.
Capì che per lui non ci sarebbe stato scampo. Attendeva rassegnato e intimidito la sentenza. Chi gli voleva strappare i libri e i quaderni, chi diceva di prenderlo a calci e a pugni, chi insisteva con una punizione esemplare e cioè spezzargli il pollice della mano destra, in modo che non avrebbe potuto scrivere per un pezzo.
Prevalse l’opinione di picchiarlo e di buttarlo dalla finestra, che per fortuna era a piano terra, per non farlo passare dall’ingresso dove l’avrebbe potuto notare il portiere.
In quel momento Saverio si accorse che c’era anche Carlo. Lo vide avvicinarsi a Guido e con sorprendente autorevolezza riuscì a calmarlo, dicendogli piano qualcosa. Tirò fuori dalla tasca mezza sigaretta e due fiammiferi e li diede al compagno, il quale subito ordinò a tutti gli altri di lasciarlo e di farsi da parte.
Carlo gli si accostò accennando appena un sorriso e gli disse: “Vai pretino, ci rivedremo presto!”
Si rividero la domenica seguente. La madre di Saverio, venuta a conoscenza di tutto, aveva voluto sdebitarsi. Vergognoso, Saverio bussò alla casa di Carlo con in mano un piccolo vassoio di biscotti e un po’ di fichi secchi infilati in stecche di canna.
Lo accolse il padre, un uomo piuttosto anziano e curvo. Carlo gli corse incontro festante. Aveva un ciuffo ribelle sulla fronte spaziosa, mani grandi, agile e alto. Ogni tanto si tirava giù la maglia blu a strisce rosse e sottili che gli si alzava dietro, perché ormai troppo piccola per lui. La sua casa era molto modesta, con pochi mobili, ma ordinata e pulita.
Diventarono grandi amici. Non passava un pomeriggio che Saverio non andasse a trovare Carlo. Lui apprendeva prontamente il latino che via via gli spiegava, Saverio restava affascinato dal modo come si muovevano le mani di Carlo quando afferravano un attrezzo.
In poco tempo Saverio imparò a piallare, ad usare tenaglie, pinza, martello, a segare, a costruire piccoli giocattoli.
Saverio metteva idee, sogni, immaginazione; Carlo lo correggeva, lo riportava alla realtà, al confronto con la “dura” materia da plasmare.
Era felice Saverio: le mani di Carlo, i suoi occhi, il suo sorriso, si accordavano perfettamente con la sua gentilezza, con la sua serenità. Saverio si specchiava in lui.
Ora anche Saverio aveva trovato il modo per assaporare le idee fatte corpo!
3- Povera me!
Mischinamia
Povera me!
Una notte d’inverno Federico venne svegliato di soprassalto dalle voci piagnucolose e assonnate delle cinque sorelle e dalla madre che, mentre andava raccattando ciò che serviva per coprire il meglio possibile, con affanno e disperazione si lamentava: “Mischinamia! Mischinamia!”
Federico intuiva che qualcosa di grave si fosse abbattuto sulla sua casa, ma non riusciva ancora a capire. Oppresso e con un nodo alla gola, facendosi forza per non piangere, indossò in fretta il cappotto e si avvolse nella sciarpa che la madre quasi gli lanciò. In pochi minuti si trovarono in strada dove già si vedeva correre gente verso le carceri.
L’urlo della sirena di allarme accresceva il senso di angoscia di ciascuno. Man mano che si avvicinavano, si intrecciavano le ipotesi. Chi parlava di fuga in massa dei detenuti, chi diceva di aver udito una forte esplosione, chi dava per certo che c’erano numerosi morti. Ad ogni voce, ad ogni passo, Federico udiva la madre biascicare una preghiera, continuamente intramezzata da: “Mischinamia, mischinamia”!
Una gran folla si accalcava dinanzi al grande portone del carcere. Qualche secondino riusciva a malapena a tenere a bada le donne che si erano avvicinate troppo alla grande inferriata centrale, dalla quale si poteva scorgere il cortile interno illuminato a giorno da un riflettore.
A un tratto si fece un gran silenzio e subito dopo si udì una voce. Un uomo, che tutti indicarono come il direttore, spiegò finalmente cosa stava succedendo. Il “lupo mannaro” quella notte di luna piena aveva tentato di evadere, ma era stato scoperto. Con l’aiuto di altri due compagni di cella ora teneva in ostaggio una decina di secondini e minacciava di ucciderli.
Sarebbe stato certamente uno “scoop” eccezionale per la televisione. Ma a quel tempo, dopo pochi anni dalla fine della guerra, non c’era ancora nessuna mobilitazione del genere. Di psichiatri capaci di convincere i malviventi, di poliziotti tipo “teste di cuoio”, nemmeno l’ombra! Il direttore doveva arrangiarsi da solo.
Intanto la folla, conosciuta la situazione, fremeva. Qualcuno imprecava, qualche donna piangeva in silenzio. Federico, unico figlio maschio, stava al fianco della madre, mentre le sorelle in fila indiana piangevano sommessamente.
In quella triste circostanza, Federico a circa nove anni ebbe la sensazione di essere improvvisamente cresciuto, diventato più forte, quasi capace di sostenere il peso di quella numerosa famiglia. Probabilmente se qualcuno non coinvolto in quel dramma avesse osservato la scena, il ragazzo doveva sembrargli il più buffo. Se ne stava dritto con lo sguardo fisso, con la sciarpa che gli copriva la testa e un cappottino logoro a piccoli quadri bianchi e neri, troppo piccolo ormai per la sua età, con le maniche che arrivavano poco più sotto il gomito. Se Vittorio De Sica si fosse trovato da quelle parti lo avrebbe certo scritturato per un provino di Ladri di biciclette!
La madre con un filo di voce disse a Federico che il padre era tra gli ostaggi. Era giunta a quella conclusione dopo aver pensato a lungo sul turno di orario del marito e sembrava non aver più dubbi.
In quel momento Federico non poté fare a meno di immaginare l’aspetto del “lupo mannaro”. Lo aveva fatto tante volte quando, soprattutto la sera d’estate, all’apparire della luna piena, insieme con altri ragazzi correva sotto la sua finestra per udire le urla feroci e lo sbattere delle inferriate. Era ormai diventato tra i ragazzi una leggenda. Raccontavano di averlo visto con una testa simile a quella di un lupo, con le braccia mostruosamente pelose e di aver udito a lungo terribili ululati.
Ora era tutto diverso. Suo padre stava lì, suo prigioniero come tanti altri.
A un tratto si sentì dall’interno del carcere la voce del direttore che con il megafono invitava i ribelli ad arrendersi e a lasciare liberi i secondini. Gli rispose un urlo di rabbia, accompagnato da un tonfo che fece gelare il sangue alla folla.
Qualcuno disse di aver visto un corpo volare. Ai piedi del muro del cortile, infatti, si intravedeva una massa scura.
Un silenzio di morte era calato su tutti. Poi altre urla e altri tonfi. Un piccolo cumulo di corpi immobili, sinistramente illuminati, giacevano nel cortile. Ora molti tra la gente piangevano e gridavano.
Passarono interminabili minuti. Finalmente si aprì lo spioncino del portone e qualcuno annunciò che non c’era più pericolo e che tutti erano salvi. Ma come salvi? E quei cadaveri in mezzo al cortile? No, per fortuna non erano cadaveri. Il “lupo mannaro” non era stato poi così folle! Non aveva ucciso nessuno, ma aveva soltanto buttato giù dei pupazzi rivestiti della divisa dei secondini.
Il padre di Federico uscì per ultimo. Li vide in fila, immobili come statue. Si avvicinò e mise un braccio attorno al collo della moglie. Dall’alto strizzò l’occhio a Federico e gli fece scivolare in mano una caramella. Fu per lui un dono doppiamente gradito, perché grande fu la sua gioia quando, scartandola, si accorse che la carta da involucro era proprio quella che da settimane andava cercando “la portoghese Catania”, per la raccolta che prometteva grossi premi.
Federico non domandò al padre dove avesse presa quella caramella. Chissà, forse gliela aveva data per lui il “lupo mannaro”.
4- Non tornare tardi
Nunn’addimurari tantu
Non tornare tardi, non ritardare tanto.
Era la raccomandazione che immancabilmente la donna rivolgeva sia al figlio quando andava a giocare in strada o a fare qualche piccola commissione, sia al marito al momento del commiato, la mattina prima di affrontare una lunga e dura giornata di lavoro.
Viene da pensare per ciascuno dei due personaggi a due situazioni opposte.
Il figlio che non torna a casa e che comunque ritarda perché nell’assolvere un incarico si comporta come il furbo tonto Giufà: beve il vino che ha comprato allo scopo di non farsi raggirare dall’oste con vino di cattiva qualità o di provare la bontà dei fiammiferi, accendendoli tutti.
Il figlio che non torna perché fugge di casa. La fuga di un ragazzo è sempre un evento drammatico per la famiglia. Allora, non esistendo la televisione che mandasse in onda programmi del tipo “Chi l’ha visto?” e non riponendo sufficiente fiducia nelle capacità delle forze dell’ordine, si ricorreva a due modalità: la prima era spicciola, non molto impegnativa, ma comunque a volte abbastanza efficace, cioè si procedeva a farlo “vanniare”. In ogni paese c’era sempre chi faceva il mestiere del “banditore”: erano sufficienti un tamburo e una buona voce. A lui ci si rivolgeva dopo aver pattuito il compenso.
L’altra via era quella che andava dritta alla mafia. Era solo per i casi più disperati.
L’interessata tentava il primo concreto approccio inviando qualche segno tangibile della sua anticipata riconoscenza. Poi, quando veniva ricevuta, messo termine alle lunghe esternazioni di benedizioni e al tradizionale bacio della mano, la malcapitata di turno esponeva il suo caso, peraltro già ben noto al capo-padrone del paese. Questi la congedava presto con un sorriso enigmatico, sia che la faccenda dovesse concludersi positivamente, sia che dovesse avere uno sbocco tragico. Alla poveretta non restava altro che sperare.
Anche per il marito il “non tornare” poteva avere due risvolti. Quello dovuto a una vendetta o punizione e quello della fuga.
Per il primo non c’erano differenze tra padre e figlio, la somiglianza della vicenda era perfetta; per il secondo, invece, non esisteva alcun confronto.
La fuga del padre, infatti, costituiva l’inizio di una vita completamente nuova. Non era raro che si perdessero definitivamente le tracce e che si avanzassero solo congetture.
Ci fu un periodo in cui le voci popolari davano solitamente per certo che il marito fosse partito per l’America, soprattutto si diceva per l’Argentina, il Brasile, il Venezuela.
Ricordo un ragazzetto della mia età, Paolo, che la sera d’estate,
riuniti in cerchio, ci raccontava abilmente dell’ultimo film western che aveva visto al cinematografo. Quasi nessuno di noi poteva disporre di quella modesta sommetta per andare a vedere un film. Sua madre, invece, gestiva un negozio e a lui non faceva mancare nulla. Ci affascinava con il racconto di praterie, di cavalli, di banditi, di indiani, di gesta eroiche, e noi pendevamo dalle sue labbra.
Una sera non venne più. Suo padre quel giorno era scomparso senza dire nulla a nessuno, era sicuramente partito senza lasciare tracce.
Venne un’altra estate, poi un’altra e un’altra ancora. Paolo smise per sempre di raccontare le trame dei film, che tanto ci appassionavano.
L’America aveva inghiottito suo padre e i suoi pensieri.
5- Mi tenne il broncio
Mi tinni a funcia, s’inniu affunciatu
Mi tenne il broncio, se ne andò imbronciato.
Può capitare che per un motivo più o meno banale, il fratello tenga il broncio alla sorella, al cognato; il figlio al padre o alla madre, l’amico all’amico o al vicino di casa. Il più delle volte ogni ombra scompare nel giro di poche ore o di pochi giorni.
In Sicilia chi s’affuncia, può restare affunciatu anche per quarant’anni e oltre!
Il maggiolino correva veloce sul nuovo ponte di Modica (vanto degli abitanti che dicono essere il più alto d’Europa), quella lontana mattina di primavera.
Il monsignore, con a fianco il giovane nipote, superando qualche raro carro, con la tonaca tirata su fino al ginocchio, guidava con grande sicurezza la sua automobile nuova, arrivata dalla Germania da pochi giorni.
Era stato il suo primo pensiero. Non aveva nemmeno dieci anni quando era successo il fatto, ne erano quindi trascorsi ben quarantadue. A Modica viveva appunto affunciatu l’unico fratello di suo padre. Nessuno ricordava ormai la ragione, ma non per questo in tutti quegli anni uno dei due fratelli aveva fatto qualcosa per riavvicinarsi.
E’ vero, vivevano in due città diverse e la distanza certamente creava un grosso ostacolo. Ma ognuno aveva pensato bene di continuare a tenere la funcia.
Ora, il monsignore che sull’altare faceva professione di amore per tutti e che predicava la riconciliazione, non poteva più venir meno ai suoi obblighi di cristiano e di prete.
Qualche tempo prima con una lettera aveva preannunciato la sua intenzione ed ora andava personalmente per ricucire uno strappo durato così a lungo, portando anche un pronipote.
Giorgio cercava di immaginare l’uomo. Lo vedeva con i baffi, altero, sprezzante, alto e massiccio come il nonno.
Quando finalmente arrivarono, venne ad aprire una vecchia con i capelli bianchissimi, che li fece entrare, dopo aver baciato la mano del monsignore.
Era una stanza molto ampia con vecchi mobili, tappezzata con quadri di santi e di vecchie fotografie incorniciate. In un angolo, improvvisamente scoppiò un colpo di tosse che si fece sempre più stizzosa. Avvolto in una coperta, nella semioscurità si intravedeva appena la testa di un vecchio.
Il monsignore gli si avvicinò e lo abbracciò senza dir nulla. La vecchia gli sistemò la coperta e allargò le braccia, poi disse: “Ecco, sono quasi due anni che non parla, non capisce nulla!”
Il vecchio mandò un nuovo prolungato colpo di tosse e a Giorgio parve che volesse dire qualcosa.
In quel momento sull’uscio apparvero quattro donne, seguite da due ragazzi della stessa età di Giorgio. Senza tante cerimonie fecero capire al monsignore che non erano graditi in quella casa e che solo per rispetto della tonaca che portava non ricorrevano a mezzi più decisi.
Era più che sufficiente quell’accoglienza per metterli alla porta.
Scesero rapidamente le scale e in pochi minuti si trovarono fuori del paese.
Poiché Giorgio non aveva capito il motivo di quel trattamento, il monsignore con un sospiro gli spiegò che quella gente aveva interpretato male il desiderio di rappacificarsi: avevano temuto che volesse portar via la roba ai parenti della moglie!
Dietro la collina, forata di agavi, il sole era appena tramontato, il cielo era stupendamente acceso di rosso. Una gazza girava in tondo attorno alla cima di un carrubo solitario.
Avevano appena imboccato il ponte di Modica, quando a circa metà dello stesso videro una figura di giovane donna salire sul muretto e gettarsi giù senza esitare. Il monsignore istintivamente accelerò e dopo pochi attimi giunsero sul punto dove avevano visto scomparire la donna. Per terra era rimasta una borsetta nera. Ansiosi si sporsero a guardare; dapprima non riuscirono a vedere nulla, poi d’un tratto in quell’orrido burrone vicino a una roccia seminascosta dai rovi e dai fichidindia, notarono qualcosa di scuro: era il corpo di quella poveretta.
Il monsignore accennò a un segno di benedizione con la mano.
Restarono lì circa mezz’ora. La gente che nel frattempo si era radunata faceva i commenti ad alta voce.
Udirono qualcuno che diceva: “Mischina, s’era affunciata con la vita!”
Vincenzo Fiaschitello
Nato a Scicli il 18/10/1940. Laurea in Materie Letterarie presso Università di Roma con il massimo dei voti (1966) e Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia nei licei classici e scientifici; pedagogia, filosofia e psicologia negli istituti magistrali (Esami di Stato D.M.10/8/1966). Docente di ruolo di Filosofia e Storia nei licei statali (Vincitore Concorso nazionale a 119 cattedre, indetto con D.M. 30/6/ 1969) e Incaricato alle esercitazioni presso la cattedra di Storia della Scuola –Facoltà di Magistero Università di Roma dall’anno accademico 1965/66 al 1973/74. Direttore didattico dal 1974 (Vincitore Concorso nazionale D.M.25/9/1970), preside e dirigente scolastico fino al 2006. Docente nei Corsi Biennali post-universitari. Membro di commissioni in concorsi indetti dal Ministero P.I. Autore di vari saggi sulla scuola, di opere di narrativa e di poesia.
Onorificenza su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Decreto Pres. Rep. 2/6/1997)
LA SECONDA PARTE DEL LESSICO SICILIANO DI VINCENZO FIASCHITELLO SARA’ ONLINE IL 24 GIUGNO
Vincenzo Fiaschitello
Nato a Scicli il 18/10/1940. Laurea in Materie Letterarie presso Università di Roma con il massimo dei voti (1966) e Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia nei licei classici e scientifici; pedagogia, filosofia e psicologia negli istituti magistrali (Esami di Stato D.M.10/8/1966). Docente di ruolo di Filosofia e Storia nei licei statali (Vincitore Concorso nazionale a 119 cattedre, indetto con D.M. 30/6/ 1969) e Incaricato alle esercitazioni presso la cattedra di Storia della Scuola –Facoltà di Magistero Università di Roma dall’anno accademico 1965/66 al 1973/74. Direttore didattico dal 1974 (Vincitore Concorso nazionale D.M.25/9/1970), preside e dirigente scolastico fino al 2006. Docente nei Corsi Biennali post-universitari. Membro di commissioni in concorsi indetti dal Ministero P.I. Autore di vari saggi sulla scuola, di opere di narrativa e di poesia.
Onorificenza su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Decreto Pres. Rep. 2/6/1997)








