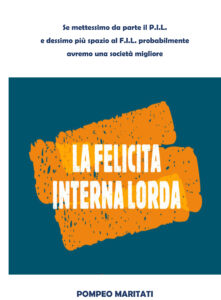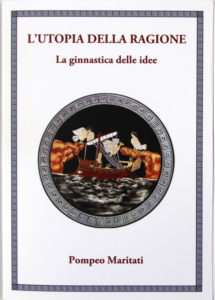Giuseppe Schirò Di Maggio e la poesia arberëshe. Metaforë/Metafora.

Di Gian Piero Stefanoni
Giuseppe Schirò Di Maggio ex insegnante, classe 1944, poeta, autore di teatro, saggista, resta di certo tra le figure più rilevanti della poesia e della cultura arberëshe in Italia. Originario di Piana degli albanesi adoperandosi a più riprese, nelle più diverse sfaccettature, per la salvaguardia e la conoscenza di una civiltà che affonda le sue radici nel nostro paese a partire dal XV° secolo, ci consegna un’opera al cui riferimento nel valore è guardato non solo nel nostro paese, o nella stessa Albania ma anche dalle minoranze albanesi della Macedonia e del Montenegro.

Di questa minoranza etno-linguistica stanziatasi in buona parte dell’Italia meridionale e insulare dopo la conquista dell’Impero ottomano dell’Albania seguita alla morte di Scanderberg, Schirò (il cui suffisso Di Maggio è un omaggio alla madre per non essere confuso coi numerosi omonimi) facendosi buon erede di quella schiera che da subito si batté per la trasmissione di un identità incisa entro un senso civico nazionale e una fede fortissima ha il merito nei testi (in versione bilingue) qui presentati a cavallo di due millenni di restituirci proprio a partire dal canto una interrogazione su ciò che resta e su ciò che ancora può dirsi, e mantenersi di tanta civiltà tra i pericoli e i passaggi di una età incontrollabile nell’uniformità delle sue direzioni e delle sue cancellazioni.
È un testo questo nata attorno al 1990 dall’intreccio tra una tournee col gruppo teatrale “Mondo albanese” e riflessioni nate da libri e racconti di amici con gli interventi del docente di lingua e letteratura albanese dell’Università di Napoli Italo Costante Fortino mirante a fissare- come ricordato da Matteo Mandalà nella prefazione- “tre tendenze, tre poetiche nella odierna poesia italo-albanese”: la prima riferita alla etnia come metafora, la seconda al paese come metafora, la terza alla terra come metafora (nei rispettivi nomi di Vorea Ujko, Giuseppe Schirò Di Maggio, Kate Zuccaro).
Nella prontezza di una risposta non polemica ma chiarificatrice, Di Maggio, ebbe allora a sottolineare dando così origine a questi versi che etnia e terra “non sono che variazioni del medesimo tema che è il paese“, nella sua figura insieme di custode etnico e terra stessa (vivendo di essa), finendo collo sciogliere infine in poesia nella sua antropizzazione, nel suo dato di “persona-umana” consapevole di una condizione di minoranza etnolinguistica esprimibile solo per frammenti, a dire dunque tutta la realtà di un mondo seppure a rischio ancora ben vivo. Un mondo splendidamente risonante in tutte le sue più intime sfaccettature dobbiamo dire, nell’attraversamento dei paesi coi quali il lettore insieme all’autore entra in dialogo o all’ascolto nel racconto di un sé carezzato, pungolato, abbracciato alla prova del moderno e di un’affacciata e sempre più avanzante globalizzazione.
E sono esattamente cinquantaquattro i centri a cui vien data voce nel raggio esatto di tutte le comunità presenti in Italia in una geografia ricchissima che dalla Sicilia alla Calabria va a comprendere il resto del sud fino alle appendici molisane e abruzzesi (nella provincia di Campobasso e Pescara), ognuna forse col sottile orgoglio di rappresentare più delle altre l’universo italo-albanese. Cosa in parte vera, in ognuna il sigillo di una verità abilmente data in tutti i suoi registri, storici, geografici, umani nell’esposizione di una sola comunità ora impotente alle aggressioni e alle malie di un progresso e di una tecnologia che va smarrendo se stessa ora pronta, fieramente pronta, abbarbicata non solo nelle sue strade, nelle sue mura, nei suoi controcanti dal mare ad una cultura gelosamente custodita nel seno della sua lingua e delle sue generazioni.
Ed infatti tutto il dettato in Schirò è in questa lotta tra la seduzione di un tempo incapace di interrogarsi nell’esercizio di sé e insieme la resistenza e l’apertura di una minoranza di uomini e donne nel rinsaldo dell’impronta identitaria di origine che trova forza nel cemento di un legame che avviene come è naturale per generazioni, là dove lingua, cultura, liturgie di fede, riti antichissimi si scaldano al fuoco di una partecipazione collettiva, come nel brano dedicato a Keiverici– Cavallerizzo di Cerceto, in provincia di Cosenza in cui tanta fiamma, a proposito di metafore, è ancora viva nell’alimento di una festa attorno al cui fuoco le famiglie nel dirsi si moltiplicano. Perché, è bene ricordare, il dettato da cui questi versi muovono non è in una sterile, vuota contrapposizione di mondi e di ragioni, di tempi ognuna nell’esclusività delle proprie aspirazioni, ma di storie tra pronunce di una esistenza che non può rinnegare se stessa e le naturali esigenze di una Storia più grande che di quelle storie sembra però non poter o non voler più nutrirsi. Un discorso questo in relazione alle minoranze linguistiche e alle problematiche inerenti una sopravvivenza sempre più fragile che non possono non riportare alla mente altre realtà come, limitandoci al meridione d’Italia volendo solo far qualche nome, quelle del griko del Salento o della comunità croata del Molise per quanto espressioni ancora più minoritarie e in pericolo rispetto a quella arbererësh.
Così è nella lingua dove la salvaguardia identitaria avviene nel coinvolgimento in nuce di una gioventù altrimenti dispersa, un tempo nel richiamo dell’emigrazione ora “nella foresta-omologazione” di “una vita non consequenziale,/ cambiate le ore, mutati i meccanismi dentati/ e le dita di metallo che le segnano”, e liberabile sempre però, ancora, dalla polvere di una cultura non più imprigionata in usanze di cui si perso il senso ma accesa nel suo esser stesso come un tempo patria per chi la perse, “punto fermo per chi ha voglia di futuri e di progresso” (si leggano, ancora dalla provincia di Cosenza, i versi da Shën Mitri- San Demetrio Corone).
L’appello come da antica invocazione va a risolversi in Schirò nel dialogo intessuto e qui restituito alla luce di una fonte di cui si avverte ancora tutta la pienezza con i grandi autori della tradizione precedente, dallo stesso Vorea Ujko a Girolamo De Rada, da Giulio Variboba a Giuseppe Zep e Karmel Kandreva e da cui insieme in una fascinazione tutta mediterranea si è risucchiati nella meraviglia e nel chiaroscuro di mondi detti il più delle volte per evocazione nella corposità di una lingua che la versione in lingua inevitabilmente può solo a tratti restituire. A partire da questo avremmo ancora molto da dire su un autore e una poesia che strattonandoci finisce coll’appartenerci, di quell’appartenenza nelle differenze data da una condizione di etnia, terra e paese più espressamente umana, ma lasciamo piuttosto nell’invito spazio al lettore nell’incontro personale con una parola e un mistero nella parola stessa eternamente rinascente, con una passione bruciante dal “più acceso degli amanti”, come nella dichiarazione in chiusura: “più delle spontanee cene in cui/si travasava vino dalla terra al sangue”.
Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta, 2005.