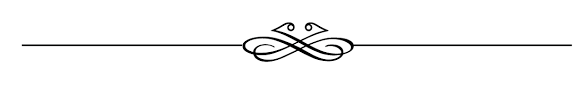3/3 – Il Profumiere Ebreo. Un racconto in tre puntate di Vincenzo Fiaschitello

Profumo-nellaria

Di stazione in stazione, il treno proseguiva fischiando, sbuffando, arrestandosi di tanto in tanto. La luce del giorno illuminava scarsamente il vagone e si alternava al buio della notte, più nero della pece, rotto a volte dal bagliore improvviso ed effimero di un fiammifero o dal suono di uno zufolo con cui, dalla parte opposta del vagone, un vecchio con i capelli bianchi diffondeva
note di struggente malinconia. Giunse voce che fosse uno zufolo speciale che quel vecchio aveva intagliato nell’osso del suo unico figlio, ucciso durante uno dei soliti assalti fascisti.
Stavano come in una camerata decine di persone accovacciate, strette fra loro, prigioniere dei loro ingombranti corpi. Un mattino, con le poche forze che ancora gli restavano, si alzò e guardando fuori lesse una scritta: Paulsen.
Isaia mormorò “Paulsen”, ma non ci fi alcuna reazione. Evidentemente era un nome sconosciuto. In realtà ancora per poco.
Era un campo di sterminio che si era acquistato una notevole fama di efficienza presso gli ambienti politici responsabili della soluzione del problema ebraico, perché il suo comandante colonnello Karl Blauser, statistiche alla mano, aveva eliminato in proporzione una percentuale di ebrei maggiore rispetto ad altri campi di gran lunga più importanti. Per questo motivo Karl Blauser era in attesa di un trasferimento ad altra sede più ambita e prestigiosa. Il Fuhrer glielo aveva preannunciato personalmente.
Prima di scendere dal treno, ciascuno raccoglieva le sue povere cose: una borsa, una valigia, un pupazzetto o una bambola per i bambini. Isaia tirò fuori dalla tasca della giacca la piccola preziosa ampolla che aveva portato con sé e, avvicinandosi con fatica verso la donna che conosceva, le disse:
-“Qual è il tuo nome?
-“ Ester”, rispose con un filo di voce la donna.
-“ Io sono Isaia, il profumiere”.
-“ Sì, lo so. Ti conosco. La tua casa profumava tutta la strada”.
-“ Ecco, odora questa essenza, ti prego”. E la segnò sulla fronte, così che quel profumo invase tutta la sua persona. Gli altri spingevano da tutte le parti e in un attimo si trovarono lontani.
Sin dall’arrivo le condizioni dei prigionieri già drammatiche si fecero ancora più proibitive. Gli ufficiali davano ordini secchi che venivano immediatamente eseguiti. Grossi cani, a stento trattenuti dalle guardie, si avventavano minacciosi contro le file di uomini, di donne e bambini che scendevano dal treno. Due medici militari, uno per la fila delle donne, l’altro per quella degli uomini, li smistavano: da una parte i più deboli, non in grado di lavorare, dall’altra quelli in condizioni migliori. Isaia fu mandato, insieme a quelli che potevano lavorare, dentro un locale dove ricevette sull’avambraccio sinistro il tatuaggio del numero di matricola, una uniforme a righe e un paio di scarpe spaiate. Si allontanò un po’, fece qualche passo verso l’ampia finestra che si apriva sul piazzale e vide quel che non avrebbe mai voluto vedere. Il colonnello, attorniato dai suoi ufficiali, seguito da guardie armate e da altre con i cani al guinzaglio, stava al centro del piazzale. Sul lato sinistro c’era una lunga fila di uomini e, più vicino, sul lato destro a poca distanza dalla finestra dalla quale guardava Isaia, la fila delle donne. A un tratto si sentì il suono dello zufolo e, contemporaneamente, si sparse nell’aria il profumo con cui Isaia aveva segnato la fronte di Ester. Un rabbioso ordine lanciato dal comandante portò subito alla individuazione del colpevole che, tratto dalla fila, fu immediatamente finito con un colpo di pistola alla nuca.
Quel colpo, quel suono, quel profumo, sembravano aver fermato per un istante la ruota del tempo. Poi cominciò a muoversi per prima la processione di quelle donne nude che andavano incontro alla morte: era il simbolo dei simboli di innumerevoli destini dell’universo femminile di ogni tempo.
Piangeva Isaia alla vista di quel passaggio: tra le lacrime intravide il sorriso misterioso di Ester, in cui scopriva più umanità che nel sorriso mistico di tutte le suore chiuse in un convento a pregare distrattamente.
Ester, ritta e magra, con i capelli sciolti sulle spalle, si muoveva con regale dignità a piccoli, ma inesorabili passi verso la grande baracca, eufemisticamente chiamata “baracca delle docce”. All’improvviso Ester si chinò e, continuando a camminare, raccolse un pugno di terra e alzò il braccio come a mostrarlo al cielo. A Isaia quella scena suscitò il pensiero di un patto, di un patto tra cielo e terra. Quello era il patto che anche ciò che è materia inerte può e vuole innalzarsi alla infinita altezza del cielo, se è fatta salva la libertà. E Ester, con tutte le sue compagne coinvolte nella stessa immensa sventura, aveva conservato saldo lo spirito di libertà: la spogliazione, ordinata dai loro carnefici, era simile a quella del poverello d’Assisi, che dinanzi al vescovo sulla pubblica piazza si svestì dei suoi abiti, restando completamente nudo. La nudità è il simbolo della liberazione non solo delle vesti, non solo del peso della bara del corpo, ma soprattutto di ogni impaccio creato allo spirito dalle ambizioni, dai desideri, dai sogni e dai tormenti, da tutti i nodi della vita, come quelli che si trovano nel rovescio del tappeto straordinariamente bello dell’umana esistenza. Quel fiume di donne si preparava a un’estasi sconosciuta, mai provata, che aveva la luminosità dell’Eterno.
Ciascuna portava l’ardore di una fede trasmessa da centinaia di anni, una fede a volte vacillante, ma sempre rinascente, riscaldata dalla parola del condottiero scelto da Dio, dal calore stesso della sabbia del deserto. E dall’altra parte, nella fila degli uomini, anch’essi nudi, ma rivestiti da invisibili sacri paramenti, era tutto il popolo di Dio che nel silenzio dell’incombente morte innalzava inni di lode a Dio. Shalom, Shalom, dicevano l’un l’altro.
Verso sera, tra coloro che già da qualche tempo si trovavano chiusi nel campo, più di qualcuno disse che i forni crematori quel giorno avevano diffuso nell’aria un fumo più chiaro e stranamente odoroso.
Nelle settimane successive, il campo di Paulsen passò sotto il comando del colonnello Martin Schneider. Questi dimostrò subito la sua umanità migliorando il rancio, abbreviando il tempo dell’adunanza al mattino presto, prolungando di mezz’ora il riposo pomeridiano. Ma la cosa più importante fu quella di proibire le punizioni brutali, cui prima i prigionieri erano sottoposti anche per lievi mancanze. Dal suo arrivo non ci furono prigionieri destinati alle camere a gas. Anche gli ebrei che arrivavano in non buone condizioni di salute, venivano avviati alle baracche e per quanto possibile curati.
Il colonnello Martin Schneider proveniva da una famiglia di profumieri: il padre e il nonno, proprietari di una catena di profumerie, gli avevano trasmesso l’arte e la passione per la produzione dei profumi.
Nel campo si era sparsa la voce che un prigioniero era riuscito con mezzi di fortuna a distillare erbe e fiori selvatici, ottenendo una essenza odorosa molto gradevole. Un ufficiale condusse Isaia dal colonnello che sapeva essere un intenditore di profumi. Il comandante apprezzò quella fragranza, ma prima di concedergli la sua fiducia, volle verificare attraverso una serie di domande la preparazione di Isaia. Così parlarono a lungo di molecole odorose racchiuse nei fiori, di essiccazione, di macerazione delle sostanze, di tempi, di quantità, del tipo di accordi che un profumo contiene: l’accordo di testa che è quello della prima impressione, l’accordo di cuore che è l’odore dominante delle prime ore, l’accordo di base o fondo che è la scia odorosa che resta per alcuni giorni. Il colonnello Martin Schneider era entusiasta, non stava più nella sua severa divisa, si era alzato e gli girava intorno, toccandosi il mento e ripetendo: “Bene, bene. Avrai tutto quello che ti serve, non hai che da chiederlo e ti sarà fornito nel più breve tempo possibile, compresi i fiori e le piante aromatiche che non si trovano sul posto”. Diede gli ordini opportuni perché Isaia venisse sistemato in un ambiente tranquillo e pulito. Da quel momento la vita di Isaia nel campo cambiò in meglio. Nessuno tra i soldati osava rivolgersi a lui in modo brusco e violento; tutti sapevano della amicizia e simpatia tra lui e il colonnello. Quando aveva bisogno di approvazione o consiglio, chiedeva il permesso di recarsi dal comandante e veniva subito soddisfatto.
Gli avevano sistemato con rapidità e precisione teutoniche un piccolo ma efficiente laboratorio con un bellissimo alambicco di rame. Tutte le essenze che via via produceva, raccolte in boccette di vetro, Isaia le consegnava al colonnello.
Trascorsero diversi mesi, durante i quali Isaia, graziato dalla sorte, si impegnò moltissimo per alleviare le sofferenze di tanti compagni che soffrivano per la fame, il freddo e le malattie. Portava soprattutto agli ammalati quel po’ di cibo che poteva risparmiare sulla sua razione più generosa rispetto a quella di tutti gli altri, E costoro lo ringraziavano e benedicevano.
Un giorno il campo ebbe l’ispezione delle SS. Il comando centrale aveva constatato già da qualche tempo una caduta verticale del numero degli ebrei eliminati. Nel corso della ispezione dei locali del colonnello, il comandante delle SS ebbe uno scatto rabbioso di odio, quando scoprì che Schneider si era preso gioco dei più alti valori militari, infinitamente stimati da ogni buon soldato. Sulla parete, sopra la latrina, facevano bella mostra la croce di guerra e due o tre decorazioni e medaglie del colonnello.
In realtà, l’ispezione era solo una formalità, perché la condanna a morte del comandante era già stata scritta, su ordine dello stesso Fuhrer.
All’alba del giorno dopo, il colonnello Martin Schneider era dinanzi al plotone di esecuzione. Il capitano, cui era stato affidato il compito di comandare il plotone, gli strappò dalla giacca i gradi di colonnello e si accingeva a ritornare per ordinare il fuoco. In quel preciso momento, dal roveto che cresceva vicino al muro, si levò il cinguettio di un pettirosso. Il colonnello girò il capo e sorrise. Ma poiché il cinguettio continuava, il capitano estrasse la pistola e sparò al pettirosso, che cadde fulminato. Poi, tornato al suo posto, diede al plotone il segnale. Martin Schneider cadde a pochi passi dal pettirosso.
Isaia, dietro la finestra del laboratorio, vide cadere il suo benefattore e improvvisamente gli vennero in mente le parole di Edipo:” Portate via il mio cadavere”. E, sapendo che il colonnello teneva sempre in tasca quello che chiamava il suo tesoro inseparabile, immaginò che aggiungesse: “Ma salvate la mia ampolla di profumo!”
I mesi seguenti furono durissimi per Isaia e per tutti gli altri, finché non giunse la sospirata liberazione.
Ora Isaia tornava nella casa del suo paese, svuotato, disancorato da ogni legame, ma con l’accettazione della trama della esistenza come qualcosa di necessario, stabilita sin dall’inizio del tempo. Il suo atteggiamento era ispirato a una sorta di stoicismo, per cui, pur nell’immensa sofferenza e ingiustizia subita, sentiva la forza per destarsi a nuova vita, come era accaduto alla magnolia, quando anni prima i fascisti che avevano dato fuoco al suo laboratorio ne avevano denudato le radici. Sicuramente aveva stentato non poco, ma ora la vedeva del tutto ripresa, verdeggiante e ricca di bianchi e
odorosi fiori.
Il chiodo dell’orrore e della degradazione, tuttavia restava conficcato nella sua anima. Aveva la sensazione che nessuno potesse credere a quel che aveva visto, che nessuno potesse immaginare come l’orrore potesse giungere a tanto, come l’odio potesse sopraffare anche il più piccolo segno di umanità e accecare gli animi. L’eccezionalità del suo olfatto gli consentiva di stratificare gli odori, li distribuiva senza sovrapporli, non solo nella realtà, ma anche nella memoria. Così preso dalla nostalgia, ricordava gli odori della sua infanzia: l’odore della scatola nuova di pastelli colorati ricevuti in regalo all’inizio dell’anno scolastico, l’odore dei quaderni nuovi e della carta stampata dei libri di scuola, l’odore della cartella di cartone che portava a tracolla, l’odore del pane appena sfornato, del dolce della nonna, del pezzo di formaggio dimenticato in fondo al cassetto del tavolo da cucina. Passava in rassegna ogni fragranza e sorrideva per quel suo viaggio sensoriale come un esploratore infaticabile. E naturalmente in tale viaggio non poteva mancare l’odore dell’acredine dei giorni amari della prigionia, l’odore della rassegnazione, della infinita desolazione del luogo, della forza brutale che tante vite avevano ridotto in fumo, un fumo che aveva impregnato ogni asse delle baracche, ogni trave e tutti i recinti e i fili spinati che negavano la libertà di quegli uomini.
Anche in paese la guerra aveva lasciato striature di odio, aveva modificato equilibri, aveva spezzato tante vite. Solo i ragazzi erano gli stessi, genuini e allegri. E come al tempo della sua fanciullezza nei giorni di calura assaporavano con gioia e curiosità la freschezza dei cortili e dei giardini delle case se solo si aprivano per un momento per l’uscita e l’entrata di chi vi abitava, I vecchi, ai quali sembrava aver ricomprato le proprie vite, tornavano a sedere malinconicamente di giorno sui gradini all’ombra delle loro case e di sera a godersi la brezza alla pallida luce della luna.
Isaia fu richiamato in servizio e riprese la sua attività di insegnamento al liceo, festeggiato dagli amici e dai colleghi. Coltivava sempre la sua passione per i profumi e cercava di mettere a punto dosaggi, mescolanze, essiccazioni, per raggiungere quell’obbiettivo da anni inseguito: trovare il settimo fiore per imitare l’antico irraggiungibile profumo.
Un giorno d’inverno gli parve di aver trovato la soluzione del mistero. Tornando da una passeggiata, aveva raccolto un mazzetto di umili fiori di bucaneve. Si ricordò di aver visto quei fiori vicino al luogo dove venne fucilato il colonnello Martin Schneider. A casa, nel suo laboratorio, provò a far
macerare quei petali e ad aggiungerli alla essenza già disponibile. Il suo fine odorato avvertì subito una fragranza che ricordava esattamente quella della ampolla del sarcofago.
Nei giorni successivi rifletté a lungo e provò con altri fiori, tutti segnati da qualche sofferenza: un fiore bagnato dalle lacrime di una madre, un fiore che aveva toccato il corpo di un malato, il fiore tenuto in un bicchiere nella cella di un ergastolano, il fiore che una donna aveva poggiato sul sangue versato da un operaio caduto da una impalcatura. Fiori di destini diversi, ma uniti dal dolore della sventura. Il risultato, annotato con scrupolo da Isaia, fu che ciascuno di quei fiori, diversi per nome e profumo, aveva dato la stessa inconfondibile fragranza. Il nome del settimo fiore che mancava nel papiro, non mancava perché il tempo aveva logorato quella piccola parte, ma perché era inutile indicarlo. Isaia lo volle chiamare, dunque, il fiore del dolore.
Qualche tempo dopo, Isaia partecipò a un concorso indetto da una profumeria di Monaco. Mandò una boccetta di quel suo profumo e conseguì il primo premio. L’invito per presenziare alla cerimonia di premiazione era firmato da Erich Schneider. Non fu difficile pensare che quello potesse essere uno dei figli del colonnello Martin Schneider.
Così la necessità manovrava destini.
Da: Vincenzo Fiaschitello: Artemisia e altri cinque racconti, Avola Libreria Urso, 2021 pp.107-132